(In Alte Terre, Paesaggio e natura delle Prealpi Trevigiane, fotografie di Antonio Piovesan, schede scientifiche di Giuseppe Busnardo, Grafiche Tintoretto Editore, Treviso, 2000)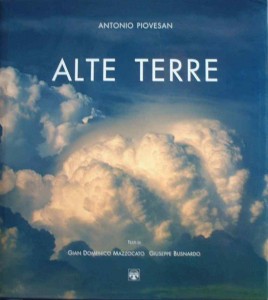
L’ULTIMO VIAGGIO
Sarebbe stata l’ultima festa.
Caterina aveva in cuore un presentimento, duro e gelido come una lama acuminata.
Da Asolo, da Venezia, da Bassano e Vicenza, dalle ville che facevano cornice al Bosco Montello, dai castelli che, simili ad aquile reali, montavano la guardia sulla piana di Onigo e di Pederobba, dai manieri che sorvegliavano lo scorrere impetuoso della grande Piave, non sarebbero più arrivati ospiti ad ascoltare mottetti, frottole e chansons in cui la voce del liuto la faceva da padrone sotto le arcate ampie del barco.
E Pietro Bembo non avrebbe più recitato i sonetti incandescenti di Francesco e i canti paradisiaci di Dante. Non avrebbe più raccontato, con la sua voce dolce e vibrante ad un tempo, le dispute amorose di Gismondo e Lavinello.
Ebbe un brivido, Caterina. La notte portava, giù dalle colline asolane, qualche refolo di aria fredda. Dal vicino borgo di Altivole, i rintocchi segnavano il trascorrere delle ore. Ludovica, la fida ancella, le si avvicinò in silenzio e le pose sulle spalle lo zendale, ultimo dono delle donne di Cipro, il giorno del congedo.
La regina si girò appena. La ringraziò col sorriso luminoso che aveva fatto innamorare quel pittore cadorino. Giovanissimo, e già tutti lo chiamavano col nome di battesimo soltanto, perché la sua fama si era sparsa ovunque.
Ma erano ormai velati gli occhi di Caterina e il suo volto ancora bellissimo sembrava assorto in visioni remote.
Era rimasta sola, sotto i grandi portici, e anche il rumore delle stoviglie e il chiacchierio della servitù tacevano. I lumi che, in direzione della prima cinta di mura, costeggiavano il lungo viale e avevano segnato la strada agli ospiti appena congedati, le apparivano con uno sfavillio confuso, come di fiamma lontana, chiusa in una teca di alabastro.
Pesava un’aura di morte e abbandono sulla campagna trevisana. E l’anima di Caterina la regina che, per singolare e ipocrita privilegio, deteneva la signoria sull’unica corte ammessa nel territorio della Serenissima Repubblica, era come stretta da una mano di ghiaccio.
Si rivedeva, Caterina, ascendere con passo fermo e il cuore in tumulto gli scalini che salivano verso la rocca di Famagosta. Aveva trentacinque anni soltanto, allora, e già aveva sperimentato ogni cosa della vita: la gioia di essere regina e madre quando ancora era fanciulla, il pianto sul corpo del suo uomo ucciso a tradimento, lo strazio per la morte del figlio, l’orgoglio per aver rivendicato, lei che aveva sangue di dogi nelle vene, indipendenza da Venezia e libertà per la sua nuova patria.
Aveva ancora negli occhi lo stendardo col leone di san Marco, alto nel cielo chiaro di Cipro. Incurante del vento impetuoso che sembrava scendere dalla lontana Morea e battere, con la stessa crudele monotonia dei remi veneziani, il mare di Grecia.
Ai magistrati di mare appena giunti da Venezia, Caterina aveva detto che rinunciava alla signoria sull’isola. La sua voce era calma e non si avvertiva l’ira disperata che, come un’onda tempestosa, le devastava il cuore.
In cambio, disse, accettava di tornare in patria, esule sulla sua stessa terra, prigioniera del suo cognome e del suo passato. A poche leghe da Venezia, inutile e in attesa della morte.
Rivide la gente di Cipro, assiepata sui moli del porto di Famagosta in quel marzo ormai lontanissimo del 1489. L’avevano salutata con gran sbandierio di panni e gli occhi colmi di pianto. Qualche pescatore, sulla sua esile sagena, si era spinto fino in alto mare per scortarla un’ultima volta.
Rabbrividì ancora, Caterina. Di lì a poco l’alba avrebbe rivelato i dolci declivi delle colline, dove il sole autunnale indorava i grappoli per la vendemmia ormai prossima.
Non ci sarebbe stata un’altra festa. Aveva deciso. Prima delle nebbie invernali, con la sua piccola corte, avrebbe preso la strada per Treviso e raggiunto Venezia. L’ultimo viaggio.
*****
VITO DELLA POIANA
Il viaggio di ritorno gli piaceva soprattutto quando poteva compierlo da solo.
Non c’era passo o sella, non c’era sentiero che Vito non conoscesse, non una mulattiera, non un tratturo. Ogni baita, ogni malga poteva essere un rifugio quando, sceso al porto di Falzè, intraprendeva la strada per tornare a Mel e magari lo sorprendeva un temporale. Risaliva il corso del Soligo fino a Follina, poi di lì piegava verso Valmareno e imboccava la strada del passo di Praderadego.
Poi cominciava la discesa verso Mel. Quando arrivava a casa, alla Nave, era notte fonda. Qualche ora di sonno e poi di nuovo pronto a guidare la zattera giù per la Piave.
Talora, invece di salire al Praderadego, prendeva a sinistra e imboccava la val d’Arc. Non erano in molti a conoscere quel posto selvaggio e misterioso. Lì, proprio a sbarrare il fondovalle, chissà quali crolli e quali acque avevano creato un incredibile arco di roccia. Quelli di Miane e quelli di Mel, dopo secoli di baruffe, avevano deciso che proprio lì passasse il confine tra i due paesi e il 6 giugno 1838 lo avevano pure inciso nella roccia, perché tutti sapessero e ricordassero.
La data era familiare a Vito, perché lui era nato proprio in quel giorno. Il nome, luminoso e breve come un lampo, sua madre glielo aveva voluto mettere per tenere lontano il mal caduto che aveva ammazzato suo padre prima ancora che lui venisse al mondo. Lei era in nove mesi e non aveva avuto la forza di ribaltargli indietro la testa, aprirgli la bocca e mettergli una scheggia di legno tra i denti.
Vito era nato quattro giorni dopo, nel dolore del parto e nello schianto dell’anima di sua madre.
Alla Nave, quattro case dove Terche e Puner si incontrano prima di andare a gettarsi nella Piave, non nasceva un maschio da molti anni. Tutti, a cominciare dal prete che lo aveva battezzato nella chiesa di Mel, trovarono che era giusto e beneaugurante chiamarlo così.
Crebbe bene, il ragazzo, senza i segni premonitori del male. La notte, sua madre si svegliava di soprassalto con la fronte sudata e il cuore in bocca. Ma Vito dormiva tranquillo e il suo sonno era profondo.
Veniva su che pareva quasi impossibile stargli dietro, bello, con gli occhi color del fiume e con le braccia così muscolose che sembravano fatte apposta per impugnare un’atola e manovrare le zattere che scendevano la corrente del grande fiume.
Sognava e aveva progetti, anche, perché era intelligente e sveglio. Imparò a leggere, a scrivere ed era veloce nel fare le somme. La poca scuola che poteva avere, gliela fece il prete il quale, nel trovar Vito così pronto ad apprendere, pensò persino di farlo entrare in seminario.
Gli insegnava che tanti secoli prima i Romani antichi avevano fatto passare di là una via importante per raggiungere le Alpi e le terre più lontane, per andare verso i confini del nord dove premevano i barbari invasori.
Prima ancora dei Romani, lì aveva abitato gente che parlava una lingua perduta. E Nave, il posto in cui lui era nato, traeva il proprio nome da una parola antica che alludeva alla felicità di quel posto: una pianura attraversata dalle acque e circondata dai monti, in cui era bello vivere e mettere su casa, anche se la povertà era tanta.
Ma a Vito pareva che in quei luoghi, nell’acqua irruente della Piave, nel Cordevole immenso che vi si immetteva proprio davanti a Mel, nel Veses che scendeva da santa Giustina, nel nome stesso del borgo in cui era nato ci fosse il segno dell’andare, dell’affidarsi alle acque che scendevano verso la pianura, convogliando in direzione di Treviso e Venezia la ricchezza delle montagne e delle vallate.
Vito fu zattiere ancora prima dei vent’anni, abile nel cogliere qualsiasi variazione nel filo della corrente, un bogolo strano, un gorgo improvviso, un’onda maligna. Lo chiamavano spesso anche all’imbarco di san Felice, qualche chilometro sopra Mel.
Bisognava saper fare di conto e alle svelte. Di là transitavano infatti i rifornimenti, i vestiti e gli attrezzi per i minatori della val Imperina, dove i padroni erano trevisani, i Brandolini, che avevano il loro feudo dall’altra parte delle montagne, verso Treviso, a Valmareno.
Vito scendeva la Piave con maestria straordinaria, giù giù, passando per Cesana dove si immetteva ribollendo la Sonna, per la Caorera e poi attraverso il passo di Quero-Vas dove le sponde erano così vicine che si poteva tirare una catena da una parte all’altra per riscuotere con più comodo il pedaggio.
Quindi ecco i passi di Segusino e Fener dove entrava il Tegorzo scendendo dalla val d’Alano. Poco oltre, il fiume di montagna rallentava la corsa per entrare in pianura e i passi si moltiplicavano: Onigo, Bigolino, Covolo e poi quello di Vidor sovrastato dall’abbazia di santa Bona. Quindi san Mama, Ciano e infine il porto di Falzè, a nord del Montello, dove gli zattieri della Val Belluna ricevevano il cambio da quelli di pianura.
Nell’esistenza di Vito, c’erano solo il fiume e l’avventura (che si rinnovava ogni giorno) di scendere verso il piano. A trent’anni doveva ancora farsi la morosa, anche se le ragazze se lo mangiavano con gli occhi quel ragazzone alto e moro, sul cui viso abbronzato gli occhi azzurri sembravano due gemme splendenti.
Sua madre smise di preoccuparsi il giorno in cui Vito le chiese di rammendargli bene i calzoni e le portò alcuni gomitoli. Con la lana di color verde doveva fargli un giaccone nuovo e con quella rossa una fusciacca che si vedesse di lontano. Bella lunga, da girarsela attorno due volte e che ne avanzasse tanto da farne uno svolazzo, quasi una bandiera. Era incuriosita, naturalmente, la vecchia donna, ma non lo faceva vedere.
Semplicemente raccontò a suo figlio come le ragazze di Mel fossero più furbe di quelle di Miane, perché dopo tanti anni di discussioni inutili si era deciso che il confine passasse nel punto in cui si sarebbero incontrate due ragazze di vent’anni partite dai rispettivi paesi al cantar del gallo.
Ma quella di Mel, che si chiamava Teresa e aveva lunghe trecce nere, fece vegliare il moroso e questi scosse il gallo inducendolo a cantare ben prima dell’alba. Teresa si avvantaggiò e l’incontro avvenne proprio sotto l’arco di roccia che tagliava la val d’Arc. Forse Teresa aveva addirittura fatto un patto col diavolo.
Nessuno seppe mai chi fosse la morosa di Vito. Lui faceva il misterioso e a chi gli chiedeva qualcosa rispondeva con un sorriso. Era buono e gentile. Un giorno, poco sotto al Praderadego trovò, impigliata nei rami di un acero, una poiana con l’ala spezzata. Si era intestardito a curarla, anche se tutti gli dicevano che quell’uccello portava male.
Invece era stato bellissimo il giorno in cui le aveva fatto spiccare di nuovo il volo. Al mattino se l’era messa nella giubba di lana verde e per tutto il giorno, mentre timonava la zattera, l’aveva sentita pulsare contro il cuore. Aveva voluto tornare proprio sul posto dove l’aveva trovata. A sera, nel bosco, si sentivano gli odori di marcita della primavera entrante.
La poiana gli era uscita di mano, toccandolo un’ultima volta, dolcemente, con i suoi artigli duri. Ma non si era allontanata.
Vito, da quel giorno, era diventato Vito della poiana. L’uccello lo seguiva, alto nel cielo, quando scendeva lungo la Piave. Gli si poggiava sulla spalla quando si fermava a far colazione, lo precedeva con volo veloce oltre le anse del fiume, quasi a esplorare i pericoli che si nascondevano al di là delle curve.
E, a sera, la madre di Vito alzava il fuoco sotto la zuppa quando sentiva la poiana aliare attorno alla casa e poi la vedeva posarsi vicino al lume, sopra la porta. Il figlio avrebbe fatto sentire, di lì a qualche momento, il suo passo traballante, abituato a cercare sulle zattere il punto di miglior equilibrio. I vecchi di Mel continuavano a dire che l’uccello non prometteva niente di buono.
Ed era un peccato, aggiungevano, perché un uomo come Vito era una ricchezza rara e, più in là negli anni, sarebbe diventato un grande contafole. Anzi, probabilmente il più bravo narratore di favole che il paese avesse mai avuto.
Infatti il giovane uomo era un po’ come il fiume su cui scendeva ogni giorno: raccoglieva ciò che sentiva raccontare. Osservava, fantasticava. E tutto formava come il deposito della sua anima. Nelle lunghe ore passate a timonare in silenzio sulla Piave, con la poiana alta nel cielo a preannunciare il suo arrivo, attorno ad un ricordo, ad una immagine, ad una fola costruiva una storia, come fa il ragno con la sua tela. Con ordine, intelligenza, trovando una radice profonda per ogni cosa, anche la più oscura e inesplicabile.
E così Vito, che non raccontava a nessuno della sua morosa, era invece bravissimo a intrattenere i ragazzini del paese. Che grande contafole sarebbe diventato.
Perché le fole sono sempre un altro modo di vedere le cose, più vero, anche se più misterioso, aggiungevano i vecchi. I ragazzi di Mel presero, ad esempio, a guardare con occhi diversi quello strano rospo dal ventre giallo che metteva nido nelle lame di montagna e tra maggio e giugno riempiva le notti delle praterie con i suoi ululati d’amore.
In realtà era un grido di rabbia e di attesa. Quando il sole estivo seccava anche l’ultima goccia delle lame, l’ululone si liberava finalmente della sua pelle di rospo e tornava ad essere il folletto birichino che infestava le notti, si faceva vivo in modo imprevedibile e giocava tiri birboni. Ma la gioia più grande, i folletti la provavano quando andavano a ballare tra le rovine delle vecchie malghe abbandonate.
Che non erano resti di muri, ma veri e propri cerchi magici, dove, nelle notti di luna piena, i folletti progettavano con ghigni tremendi gli scherzi da giocare nei giorni a venire. Poi con la brutta stagione, alle prime piogge, i folletti erano condannati, in un giro che durava dalla notte dei secoli, a tornare rospi.
Ma la fola che a Vito riusciva meglio, perché poteva cambiarla all’infinito, era quella dell’allocco. La allungava, le faceva imboccare strade imprevedibili, la accorciava, la riempiva di invenzioni sempre nuove.
Infatti l’albero dal quale, a starci bene attenti, si vede a volte affacciarsi con i suoi grandi occhi tondi l’allocco, non è un albero come tutti gli altri. Bisognava sentirlo cantare il vento, stando dentro a quell’albero e scendendo giù per la scala ripidissima ma sempre più larga che conduceva ad un numero infinito di grotte.
Vito c’era stato, naturalmente, e poteva raccontare per filo e per segno quello che aveva visto, di caverna in caverna. Entrare non era stato facile perché l’allocco lo aveva guardato proprio male, ma poi la sua poiana aveva fatto tre o quattro giri attorno all’albero e l’uccello guardiano si era tranquillizzato. Chissà come si erano capiti…
Le prime grotte erano piene di tesori, di oro, di perle, di monili e bastava accendere un ramo intriso di resina per vedere brillare e sfavillare montagne di metalli preziosi. Ma Vito, come tutti vedevano, non era ricco e per sbarcare il lunario doveva ammazzarsi di fatica tutti i giorni sulle zattere. Naturalmente non bisognava lasciarsi fuorviare o distrarre. Se uno si fermava alle grotte dei tesori, si perdeva il meglio.
Le grotte successive erano tanto più spettacolari e interessanti. Esse ospitavano infatti i grandi laghi da cui nascevano tutte le acque della montagna, della val Belluna e della val Lapisina e anche tutte le acque che per via misteriosa andavano ad alimentare le risorgive di pianura. Perché tutti i fiumi, dal più grande e impetuoso al più povero rigagnolo, hanno un’unica madre, una sola sorgente. Proprio lì, sotto la montagna.
E poi come era bello vedere gli aceri, i larici e i faggi dalle parti delle radici. Si capiva come era la vita stessa, come la linfa nutriva ogni ramo, ogni più piccola foglia. Ma lo spettacolo più incredibile erano le fondamenta dei grandi castelli di Cison, di Follina, della Valmarena e delle mille rocche, possenti o minuscole (magari un torrione appena) che presidiavano montagne e colline.
C’erano anzi passaggi segreti attraverso i quali ci si poteva introdurre in ogni castello e conoscere i segreti dei loro padroni. Vito, quando gli veniva l’estro, raccontava di delitti rimasti segreti, di persone murate vive, di prigionieri sepolti nelle segrete. Anche l’arco di roccia che chiudeva la val d’Arc aveva radici profonde e proprio lì sotto i diavoli organizzavano i loro convegni per discutere su come tenere accese la rivalità e le baruffe tra Miane e Mel. E che dire dell’abbazia di Follina con i suoi immensi muri sotterranei?
Tutto aveva veduto e conosciuto, Vito. I ragazzini sognavano e sgranavano gli occhi. Non c’era dubbio. Sarebbe divenuto il più memorabile contafole della vallata. Ad ascoltarlo sarebbero giunti da oltre il Praderadego, da oltre il san Boldo, dal Combai, da Tovena e da Premaor, da Belluno e anche da più lontano.
Ma era proprio vero che la poiana portava male. Una sera d’autunno la mamma di Vito (era ormai vecchissima e i suoi occhi non vedevano più) sentì l’uccello sbattere le ali sulla porta.
Era inquieta da qualche ora senza sapere perché. I minuti e le ore passarono senza che risuonasse il passo di Vito.
Lo zattiere bravo a contar fole non tornò mai più. A sua madre si spezzò il cuore, qualche mese dopo. Vito, si disse, era precipitato nella gola stretta e impervia che separa il castello di Zumelle da quello di Castelvint, in un passaggio noto a lui solo. Forse si era spinto là per abbreviare il viaggio, forse voleva cogliere il fiore raro e bellissimo che sbocciava una sola volta all’anno e solo in quella gola orrida.
Anche la poiana non si fece mai più vedere.
I ragazzini di Mel sapevano però benissimo che Vito stava vagando tra le grotte immense, sotto l’albero dell’allocco e che prima o poi sarebbe riemerso per raccontare la fola più lunga, più incredibile, più luminosa che mai si fosse sentita. E per molti anni i fanciulli della val Belluna, fattisi uomini e poi vecchi, aspettarono una poiana che aliasse leggera sulla porta della casa abbandonata, alle foci di Terche e Puner.
Vito sarebbe arrivato di lì a qualche minuto, col suo passo rapido e traballante da uomo del fiume.