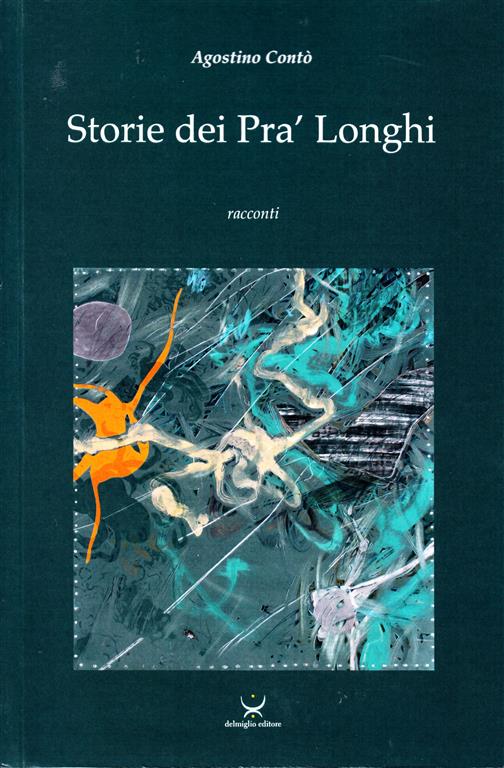(PREFAZIONE A STORIE DEI PRA’ LONGHI DI AGOSTINO CONTÒ)
di
Gian Domenico Mazzocato
…questa cosa era fatta di notte, che nessuno doveva sapere…
(Storie dei Pra’ Longhi, Per introdurre)
Per chi, come me, non riesce a reggere la noia delle prefazioni, rimando all’ultima riga. C’è, in sintesi, già tutto.
Da una vita leggo e decifro Andrea Camilleri (Montalbano e non) e da una vita mi dico: come mi piacerebbe scrivere in veneto allo stesso modo in cui lui scrive in siciliano. Con alibi mentale e culturale pronto, tuttavia: Camilleri scrive in una lingua letteraria che è quasi millenaria e che discende da Federico II, da Jacopo da Lentini, Cielo d’Alcamo e Oddo delle Colonne. Qui da noi è altra storia, purtroppo. Che lingua letteraria può / potrebbe mai essere il veneto? Alibi facile e tranquillizzante.
Fino a lunedì 27 giugno 2016 (nell’agenda della mia esistenza cerchierò la data rubro lapide): in questa giornata (tuoni e fulmini all’alba, sole radioso per il resto delle ore, vorrà pur dire qualcosa) Agostino Contò ha preso a calcioni il mio alibi. Ha svelato una lingua possibile. Ha preso a pugni la mia compita e compiuta sintassi, la mia idea di punteggiatura (più che altro l’ha completamente cassata), le mie certezze ortografiche. Ha scempiato doppie. Ha slabbrato, deformato, contorto, tirato per i capelli, fatto urlare e sussurrare un lessico mai sentito. In una parola ha costruito uno strumento perfetto, un meccanismo da orologio svizzero. In cui tutto torna.
Lessico che però viene da lontano e ha picchetti profondamente infissi: una tenda solare, in cui abitare con speranza. Da disfare e mettersi sulle spalle per scoprire novità. Per esplorare nuove zone del ricordo. Gli starti, le sedimentazioni, le incrostature.
Mai dimenticando però l’imprinting della dell’uomo di raffinata cultura. Quel “mi sovviene allor che ci disse il vecchio a mio papà” è sintesi e paradigma.
Ha, Agostino, buttato per aria anche le mie idee grafiche di antico giornalista venuto su a piombo e linotype, precipitando dal sasso tarpeio corsivi, neretti, segni diacritici. Ha fatto tutto ciò nel modo aureo e generoso che appartiene agli scrittori di razza, regalandomi il privilegio di condividere queste Storie dei Pra’ Longhi.
“Ti mando l’impaginato, dice in sintesi la mail di accompagnamento, dacci un’occhiata”.
Capisco subito che un’occhiata non basta. Bisogna bere, assaporare. Metterci lingua, palato e anima. Socchiudere gli occhi, fare pause frequenti e aspettare che l’onda delle emozioni decanti e si filtri. Mi trovo subito a mio agio.
Come ero uso a fare uno dei miei grandi padri spirituali, Fulvio Tomizza, è immediatamente geografia.
La geografia delle famiglie, nomi e soprattutto nomignoli, caratterizzazioni, distinzioni. Ne so ben qualcosa. Mia moglie è una Zanatta dei tanti ceppi Zanatta di Arcade. Per distinguere, la sua famiglia era quella dei muneri.
Famiglie dal blasone miserabile.
Proprio perché miserabili e oscurate dalla storia, nel gioco duro della sopravvivenza, hanno bisogno di diventare carne (nelle parole memoriali del narratore, voglio dire) e creano archetipi.
Alle svelte, sennò la memoria si liquefa, si perde nelle nebbie. La madre che partorisce un prematuro bambin gesù la notte di natale. Il padre soldato che scende in cantina, tira un’ongiata alla mela perché si guasti. E così gli sarà concesso mangiarla il giorno dopo. Zio Bortolo che mette su banda (nel senso di banditi, non di complesso musicale) col papà e con un amico clarinettista per rapire succulenti capponi. Eccetera. Dico così, per sommi capi e in cifra, per non rovinare il piacere della scoperta. Le genealogie e gli anticristi, irriferibili memorie di bambini morti soffocati (forse) e di adulti consumati in sanatorio. Le postine zitelle, il violinista Zinzin (in forza evidente di un’aurorale onomatopea) e la gattara cui si attaglia benissimo il nome di una maga da poemi cavallereschi. Da regina di prati niente affatto incantati.
Dio, che galleria sconvolgente. Dentro all’altra geografia, quella fisica, quella dei muri. La chiesa dei preti e la chiesa laica, cioè l’osteria, le poste: al borgo si arriva seguendo una strada bianca. Il colore c’entra solo da lontano, bianca vuol dire sterrata.
Si capisce che si è lì, proprio lì, per via del capitello. Contò non si limita ad affascinare. Coinvolge e travolge. Non ti lascia respirare. Incalza.
Appena più in là conosceremo la Piangi-Ridi della Dele fottuta e rifottuta dai cento soldati in ritirata e la perversa pedofilia di Mattio, peraltro già scritta nei suoi occhi folli. Ma la storia di Mattio Mattio col servèlo descusìo è ben altro.
Il racconto dedicato alla figura di Sante (al quale un esproprio vuol portar via la terra) sa di liturgia laica, una vera e propria transustanziazione (“Il suo vino è pronto”, che lo assaggi, che senta se ghe piàse che son brave figliole le sue figliole, di chiesa…”). Lui, Sante, non l’aveva voluta vendere la terra quando era tempo, e ora…
A Sante grandina sulla testa. Si trova con le figlie puttane e un figlio scappato, come recita l’epitaffio -senza ombra di cristiana carità- che il prete pronuncia quando la moglie lo trova impiccato.
Che umanità dolente e dolorante. Vive e respira proprio quando rinuncia a vivere, pulsa come sangue ferito proprio quando muore.
Si muore di disperazione e di vino. Che è un po’ la stessa cosa perché, a bere, ti metti quando sei disperato. Come capita a Viae, il padre di Nino il nano, sulle ali di una meravigliosa assonanza.
E poi Abramo, nero fantasma e nero tabarro. Poi ancora la Pina Caìna che “fa tappare le sporche bocche che prima la volevano giovine per nulla solo per i suoi tettoni ché ad ingravidare una zoppa caìna non c’è poi pericolo di doversela sposare”. E…
E basta, mi fermo qui.
Come ho già detto: travolto. Aggiungo: emozionato, determinato a rileggere e a soppesare ogni situazione ma anche ogni giro di parole. Le storie che abitano la geografia dilatata (e, ad un tempo, piccola, molto confinata) dei Pra’ Longhi avevano bisogno di una narrazione di taglio epico ed ironico insieme. Affettuoso e nostalgico. Mi verrebbe da dire: nostalgico ma cattivo. Nessuna sbavatura. Mai retorico, senza enfasi e con il ciglio asciutto. Che sapesse fare delle vicende di un piccolo borgo dimenticato da Dio, un luogo universale e riconoscibile.
Mix impossibile? Leggete, cari amici, leggete. E, se volete, cominciate dall’Epilogo. Che è una lettera. Scritta, a ben vedere, al lettore. Contò vi dà le diritte giuste, le chiavi di lettura, come si dice. E naturalmente racconta, aggiunge narrazione a narrazione.
“Ché dopo tanti anni non capisco bene per quali strane vie, mi si presenta al telefono un signore molto per bene e mi chiede della carta che aveva mio nonno, recuperata forse in periodo di guerra, della prima guerra”. Che è storia furba, ma anche enigmatica, perfino misteriosa.
Ci diciamo: ma non sarà mica finita qui, vero, la galleria di personaggi del borgo cui si arriva dalla strada bianca? Riprovaci, Agostino. Non essere avaro di te. Prosegui te stesso.
Perché davvero i Pra’ Longhi hanno un respiro largo, si fanno immagine possente ( e grande, generale) di umanità disperate e impegolate nel malessere esistenziale. Le umanità che non hanno progetti.
Con Storie dei Pra’ Longhi, Agostino Contò piazza autorevolmente la sua carega accanto a quella di Luigi Meneghello. Per l’uso della sintassi e per la capacità di recupero di zone inesplorate dell’anima siede accanto a Giuseppe Berto (ma è meno letterario, più ruspante, più terragno. Insomma più vivo). Inoltre, per la beatitudine scavata e pietrificata del suo dire, Agostino può trascinarsi la carega vicino, ma proprio vicino a Elio Chinol e all’aura che promana dalla sua Vita perduta.
Ah, già: sono debitore di un’ultima riga. Grazie Agostino, amico mio. Tutto qua. Grazie dal profondo. Genio, creatività, input, memoria. Un mondo restituito. Che libro, amici miei, che libro.