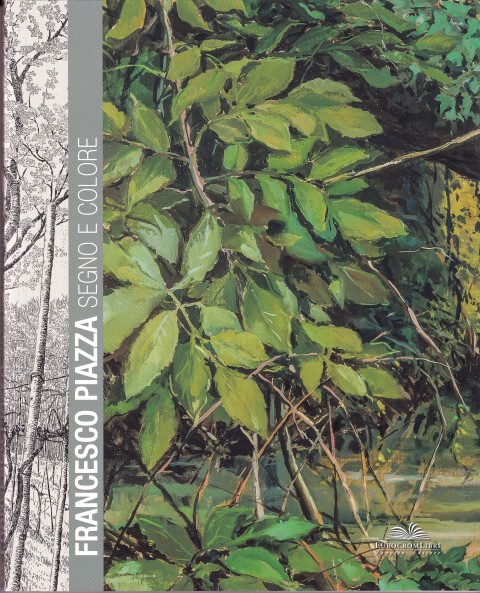di GIAN DOMENICO MAZZOCATO
Sarà l’odore di incenso
che emana la lastra,
sarà il profondo dolore
che mi frequenta l’anima
…
Francesco Piazza
Tutta la natura è protesa verso un “tu”.
Tutti gli esseri viventi sono in comunione.
Gli uni con gli altri.
Ernesto Cardinal Martínez
Nel 1948 Francesco Piazza ha 17 anni.
Vive i giorni della ricerca e delle curiosità. Prova tecniche e linguaggi. Dipinge a olio su tele di sacco. Sperimenta colori a tempera su tavolette che trova qua e là. Le mette in forno ad invecchiare. Dice che così fa trasalire i colori.
Abita in una soffitta, al centro di Asolo. La casa odora e puzza di colle, di latte ammuffito, di chiara d’uovo e di bitume. L’aria si impregna dell’acido nitrico delle prime, spericolate morsure. Piazza è in dialogo serrato e libero con la materia del rappresentare, con i supporti fisici della sua ricerca. Il colore, la tela.
E il rame, la cera, gli acidi delle incisioni.
L’acquaforte entra così nella sua vita. Sommessamente e trionfalmente.
Con, in prima istanza, quella abilità che solo gli acquafortisti sviluppano e possiedono. È il primo segreto del loro mestiere: creare artigianalmente le punte di acciaio utili a incidere la cera e prepararla ad accogliere l’acido nitrico (l’aqua fortis degli alchimisti) fissandole su basette di legno. Piazza utilizzava spesso, come supporto, anche pezzi di sughero.
A questi strumenti autocostruiti, in assenza di un termine proprio, si dà il nome di bulino mutuandolo dalle tecniche di incisione diretta della matrice di metallo: bulino, appunto, niello, puntasecca (e anche la cosiddetta maniera nera in cui ai bulini si accompagnano raschietti e brunitoi).
Piazza è disordinato e smarrisce la sua prima lastra. Vi aveva inciso, guardando il paesaggio dalla terrazza della soffitta, un po’ di periferia con della siepe e un alberello spoglio e un solicino invernale.
Ne conserva (e forse ne tira) un’unica copia, che il tempo ingiallisce in fretta perché sta sul muro dentro una cornicetta senza vetro. Tanto che anni dopo attribuirà il titolo di prima acquaforte, come dire, ufficiale ad una incisione del 1949 (La casa dei Romano, prima acquaforte della mia vita).
Nel 1954 vince il primo premio alla Mostra del Bianco e Nero di Cittadella. L’incisione (San Nicolò, 1952) lascia intravedere in lontananza la basilica trevigiana. Il tempio è sfumata e brumale filigrana. Il punto di osservazione di Piazza è tra filiformi arbusti colti in primissimo piano. In mezzo, campi e vigneti. Una sorta di preannuncio, di summa ideologica della sua arte, a ben guardare.
Sono anni di esposizioni con l’approdo prestigioso alla Biennale di Venezia. E sono soprattutto i tempi in cui matura il suo rapporto con Anna Maria Feder.
Tuttavia l’entusiasmo per l’acquaforte, l’accensione per il segno inciso sulla cera in attesa del morso dell’acido, albergano nell’animo di Francesco per un periodo abbastanza breve. Fino al 1956, i suoi 25 anni.
In quel periodo prende il diploma di maturità artistica, indispensabile per affrontare a viso aperto il futuro e severo suocero. L’anno successivo trova lavoro presso le Grafiche Trevisan di Castelfranco.
Sono le stagioni del rimescolamento, della nuova costruzione di sé.
E l’acquaforte sparisce dalla sua vita. Perché mi parve di non avere più la quiete, la serenità, i tempi lunghi necessari per quel tanto di introspezione, di solitudine, di tranquillità spirituale che ti fanno godere il dialogo con la lastra.
È la prima, fertile stagione di Piazza incisore. Smorzatasi nel silenzio. Nonostante i rimbrotti della sua donna, Anna (Gigio mio, finisci la Madonna e cerca di stampare!, gli scrive in una lettera).
Recupera il ritmo ideale per incidere nel 1974, quasi venti anni dopo.
Ha studiato, ha riflettuto, ha conferito spessore e grazia ulteriori al suo mondo poetico. Riemerge il fiume impetuoso che ha viaggiato a lungo, per itinerari indecifrabili, sottotraccia: attende solo l’attimo giusto per affiorare.
In una parola è il gioioso ritrovamento del primo amore: vi si accosta, confida, con trepidazione e paura. La trepidazione si nota in ogni istante del processo che porterà alla lastra compiuta.
Piazza butta giù qualche schizzo e quindi rifinisce il disegno su un foglio di carta translucida. Poi gira il foglio perché la lastra è, evidentemente, una sorta di negativo.
È la realtà rovesciata, nella dimensione dello specchio. Ed è già una misura “altra” delle cose, straniata e misteriosa. In cui l’emozione gioca talora tiri birboni. Capita infatti, soprattutto nel primo periodo, di vedere lettere e numeri rovesciati.
Ma il meccanismo creativo è in movimento. Innescato da un atteggiamento di umiltà e da quella folgorazione che egli chiama fotografia spirituale.
Piazza analizza nel corso di una intervista, non a caso in confronto dialettico con un fotografo: il lavoro dell’artista ha bisogno di un atto di umiltà iniziale: l’apprendimento di una tecnica. Per comunicare non è sufficiente un linguaggio istintivo, primordiale. Incontrando un paesaggio devo calcolare che il mio lavoro durerà ore e ore. Molte cose cambiano in questo tempo, prima fra tutte la condizione della luce, perciò io devo percepire il mio soggetto in un attimo nel suo insieme, scattando una “fotografia spirituale”.
In un’altra intervista, anni dopo, Piazza riprenderà il tema: insomma, io voglio far riacquistare all’uomo il senso del paesaggio, lo invito a entrarvi pacificamente.
In questo periodo Piazza si è anche confrontato col mercato. Non quello dell’arte, quello del mondo pubblicitario.
Ha idee geniali, di incredibile pulizia immaginifica: il design di una bottiglia per grappa reca qualche lira nelle sue tasche e una fortuna in quelle del committente.
Appunto, lire poche.
Dunque, a riportarlo sulle tracce del segno acquafortistico, è anche la necessità di trovare una strada definitiva. E sono gli amici a rimettergli tra le mani tutto il necessario. Il bulino e le lastre, le vasche e gli acidi.
Dopo qualche mese, arriva anche il torchio che evita pellegrinaggi presso stamperie aliene.
La vocazione riprende vigore.
Riscoperta di tracce perdute, ritrovamento di un cammino trascurato.
Questo nuovo disvelarsi della musa è fondamentale, decisivo.
Piazza avverte che l’acquaforte è il mezzo espressivo che mi soddisfa di più se devo comunicare sensazioni, determinati godimenti spirituali.
Il fatto è che l’acquaforte coincide compiutamente con il mondo della sua ispirazione e dunque lo esprime in modo completo, esaustivo.
È docile, l’acquaforte, e obbedisce alla voglia di raccontare con tranquillità ciò che a olio viene narrato impetuosamente, ansiosamente.
Anche se il punto di equilibrio va individuato e stabilizzato di volta in volta.
L’ispirazione è istintiva e primordiale, talora caotica, bruciante e fluviale. Incidere richiede, invece, meditazione, pensiero riflesso, tempi lunghi e pacatezza. Domanda soprattutto mediazione intellettuale e rigoroso filtro culturale.
Equilibrio. Dunque ricerca di contrappesi, la proporzione e l’armonia, la coerenza e la saggezza.
E, in un suo scritto, Anna Feder circoscrive con sensibilità struggente il mondo della loro casa come luogo in cui prende a respirare l’arte di Francesco. Il luogo dell’armonia: questo delizioso angolo che non conosce frattura tra l’armonia delle cose e della natura e l’armonia delle persone…
Per noi, oggi, incamminarsi su questa strada significa, con evidenza e verità, inseguire una chiave di lettura complessiva.
Che sia utile e funzionale a intendere -in diacronia e sincronia, nel complesso o nel dettaglio- l’intera opera artistica di Francesco Piazza e in particolare l’opera grafica.
Dove non ci sono codici complessi da decifrare perché la richiesta che l’artista pone al suo fruitore è di altro tipo: cogliere il farsi del tempo, della memoria, il loro stratificarsi, il sedimentare più o meno veloce.
Una sorta di impegnativa empatia che liberi alla contemplazione e immerga nel fluire del pensiero. Piazza immaginava così il rapporto con chi guardava alla sua opera. Un possesso alla pari, un discorso giocato su tre vertici. L’artista, l’opera e il fruitore.
Fruitore? L’uomo, verrebbe da dire, l’uomo tout court.
Perché, spiega Piazza, l’uomo è mio amico e io lo invito ad entrare nelle mie immagini. Ne faccia lui quello che vuole. Io ho visto cose belle e ho voglia di fargliele vedere. Se scopro quanto è affascinante una siepe, lo chiamo a scoprirla pure lui, a guardarla, a non dimenticarla quando sparirà perché urgono le esigenze della vita.
Insomma, immerso nel tempo lungo di un’acquaforte che richiede introspezione e domande, l’artista non desidera scavare nell’uomo con la stessa curiosità e con lo stesso cipiglio critico che può usare davanti ad un muro, a un fiore, a un albero che fanno parte del mio possesso.
In effetti, se escludiamo i ritratti che implicano un discorso particolare e autonomo, l’uomo, inteso come presenza corporea, come peso fisico, non attraversa mai (quasi mai) l’opera di Piazza. Piuttosto l’uomo è avvertito come interlocutore necessario, analizzato come un’esigenza dell’opera stessa e della riflessione che questa schiude e propone. L’uomo è vocato, chiamato dall’artista.
Piazza sa con acutezza (e talora con sofferenza) che non esiste opera d’arte finita. Che essa si fa in continuazione nell’incessante evocazione dell’interlocutore.
In una sua lettera del 1986 (la malattia sta bussando forte, una seconda e definitiva volta, alla sua porta), Anna Feder scrive: Checco ha fatto per me un’acquaforte eccezionale. Non che l’abbia fatta “per me”, ma “secondo” me. È un’acquaforte di burattini. Si tratta di un genere un po’ nuovo per lui, ma non si direbbe. Anzi, si direbbe l’opposto. E con ciò noi non vediamo che l’uomo, come tale, Francesco lo salta sempre. Checco passa dall’incanto della natura che offre a tutti come contemplazione allo scavare sulla natura umana della quale non ha altissima opinione, benché singolarmente ne abbia estremo rispetto e compassione, per cui ne escono questi burattini col volto umano e le gambe molli. Ma mai, credo, inserirà l’uomo come tale nelle sue tele perché per lui l’uomo può essere il fruitore di qualche cosa, non un oggetto da fruire.
Tutto aiuta a conferire completezza al perimetro e stimola a riconoscere il ruolo della didascalia che, con l’evolversi dell’iter artistico di Piazza, si è fatta sempre più significativa -centrale, se si può dire- nelle incisioni.
Nel suo trasformarsi, nel farsi complessa e ampia negli anni, è essa stessa, in modo autonomo, indice della ricerca di un linguaggio parallelo.
Non solo perché, come dice Piazza alludendo con forza all’aspetto maieutico del proprio lavoro, incidere è stare per ore insieme con la lastra. Tanto che vien voglia di parlarle, di completare l’immagine che in essa sta nascendo.
La didascalia non è solo sintesi, non è soltanto indicazione di una strada diversa per giungere alla stessa verità rivelata dal quadro.
È soprattutto un rilancio, la parola che attende di essere pronunciata e ripronunciata. Rinnovata ogni volta da una diversa enunciazione.
Vibrano tutta l’umiltà e la luce grande di Piazza in questo: egli accetta di dirsi e raccontarsi chiedendo a prestito parole altrui, in prevalenza versetti del Salmista.
Il rapporto immagine / didascalia ha coniugazioni e articolazioni alte e talora altissime. Perfino misteriose e insondabili perché l’evidenza del segno cerca e crea connessioni profonde con la capacità evocativa della parola in una perenne novità sorgiva.
Ansia, desiderio di dire. In quei momenti si incontra, oltre alla gioia, la sensazione della propria impotenza: rimane sempre qualcos’altro da dire. Le parole, comunque, fanno parte del mio modo di trasmettere emozioni.
La didascalia reclama un ruolo non subalterno rispetto all’immagine perché la parola ha tale forza orfica e colmativa che, ben lungi dall’eludere il confronto con l’immagine stessa, ne esalta piuttosto la percezione, circoscrive l’area sentimentale, emozionale, estetica, filosofica in cui essa va intesa.
Anzi: l’artista indica con mansuetudine un’alternativa a se stesso, una complementarietà al suo dire per segni grafici. E al tempo stesso, forte di una rivelazione che rinsalda e sostiene il suo mondo poetico e morale, accende con mano ferma la lampada che non può stare sotto il moggio perché deve spandere il fascio di luce sulla struttura del creato.
È consapevole e orgoglioso di quello che fa. E indica.
La strada da seguire nel buio, la lanterna appesa al vincastro che guida i passi, il possente chiarore che si intuisce oltre le tenebre.
Un poderoso, stringente sentimento del tempo. Da raccontare e testimoniare perché solo in questa logica, gioiosa e dolorante insieme, si coniuga e si autodichiara la funzione dell’artista. Un cilicio, il tempo, che si aggrappa alle carni e ricorda a ogni movimento la propria presenza. Assilla con la forza irruente del dubbio.
Piazza argomenta con giro affascinante e arguto: il tempo che è passato è perduto. Si vorrebbe poter descrivere come lo si è vissuto agli amici che sono venuti, agli amici che vengono. Metterlo in comune. Goderlo o dubitarne insieme.
Il messaggio è forte. Piazza possiede estro, gioia (che spesso si ribalta, con paradosso solo apparente, in tristezza pensosa), profondità, filosofia, tecnica per rendere un mondo (che è per definizione alieno: il suo mondo, la sua ispirazione, la sua poetica) accessibile e condiviso nella sua interezza.
L’opera approda dunque a stabile e consolidato equilibrio: comprensibile a tutti ma ancorata alla coscienza dell’artista che la rende viva e perenne con la sua linfa. Che è appunto misteriosa e intima fusione di immagine e parola. In tale innervatura si colgono sforzo di autenticità e ricerca di assoluto.
La ricerca, nel suo affabulare, si lega alla speranza: io avverto che c’è, nelle cose, un messaggio indirizzato all’uomo, uno dei tanti doni, compreso il fatto di amministrare l’universo. L’uomo ha un legame con l’universo, deve tornare in sintonia con il creato. Capire questo, ritrovarsi in questo dà speranza.
L’artista si spende, generoso, in ogni istante e in ogni fase del proprio lavoro. È consapevole di essere sulla strada giusta: c’è una purezza da raggiungere. Serve un filtro che elimini la durezza dei tempi materiali dell’esecuzione e lo stratificarsi dei maestri e delle scuole. Che depuri, anche, le scorie dei modelli pensati e ripensati. E tuttavia non li faccia dimenticare.
La punta del bulino è arma affilata e consente un duello alla pari col tempo. Delinea, attraverso la simbiosi immagine / parola, un metodo di ricerca: individuare, nel paesaggio noto e rivisitato giorno dopo giorno, qualcosa di sconosciuto, fresco, inedito. Una originalità che mette in comunicazione col metafisico e con l’assoluto. La sorgente che fa zampillare l’acqua di sempre, perennemente nuova e diversa. Forza immane, a ben vedere.
Tornano in mente le parole che Camillo Boito spese per i Tiepolo, dichiaratamente magistrali rispetto all’arte di Piazza: Giambattista (ma i suoi favolosi e misterici Capricci sono lontanissimi dalla temperie di Piazza) con i figli Lorenzo e soprattutto Giandomenico, il divino disegnatore. Il grande architetto e restauratore definisce insolente la fantasia dei Tiepolo. Certamente in senso etimologico: fuori del consueto, straordinaria, inimitabile. Un comporre di miracolosa abbondanza, sottolinea Boito.
Già, il miracolo e l’abbondanza, il prodigio e la ricchezza.
Piazza ebbe una volta a citare il domenicano Marcel-Denys Forestier, uno dei padri dello scautismo cattolico: a partire dal momento in cui l’opera d’arte è creata, è un’entità che testimonia dell’uomo ciò che sfugge a lui stesso. Vale a dire che lo supera e che nello stesso tempo è presente a lui.
Dentro alla dialettica tra immanenza e trascendenza si colloca l’arte di Francesco Piazza. Tra la sofferenza che viene dalla nodosa, tortuosa fatica di leggere la realtà e la gioia della scoperta di una novità perpetua.
Il cilicio abrasivo e severo della fatica creativa e l’ascesi dell’invenzione catturata e divenuta realtà oggettiva nel segno del bulino. Il tempo e l’istante.
Il carisma profetico dell’arte consente di comprendere lo sbigottimento e la confusione del nostro tempo, avvertiva Piazza.
L’artista è dunque un (ri)ordinatore dell’esistente. Romanticamente (ed eternamente) comprende il proprio tempo e, con pazienza, tesse la tela di una sua nuova possibile impaginazione ideale e alternativa. Trama e ordito.
Allinea davanti al fruitore gli oggetti della quotidianità, ma li sistema e li organizza secondo inventari affatto originali, compila cataloghi inediti. E chi si pone davanti al suo lavoro riconosce il quadro complessivo della propria quotidianità, la materia del reale con cui fa i conti ad ogni istante. Ma vi ravvisa anche relazioni nuove, suggestioni nuove, regole di comportamento nuove. Piazza sa tutto ciò con pienezza e chiama attenzione. Con voce chiarissima, di cristallo.
Perché, nell’attimo dell’estasi, riceve e subito dopo propaga agli altri la rivelazione ultima: lui, l’artista, è collaboratore della creazione.
Dio ci dà in questi momenti la vertiginosa possibilità di essere insieme a lui creatori, di trarre dal nulla cose belle e inestimabili, scrive Piazza. E soggiunge che ciò gli conferisce un’emozione particolare: questa sensazione di enormità mi spinge a testimoniare l’esigenza della spiritualità. Essa mi è venuta dall’applicarmi onestamente in questo “mestiere” inteso nel senso del “mistero”. Insomma, il dualismo di cui si sta parlando e che ci introduce alla dimensione di sacralità dell’atto creativo.
E disegnando il nocciolo duro del suo mestiere / mistero: l’artista ha un carisma naturale primigenio e dev’essere coerente con se stesso. Gli artisti hanno un dovere da compiere. Quando io parlo di coerenza, intendo che ognuno deve fare i conti prima di tutto con se stesso. Io credo nella spiritualità e nella religiosità dell’artista, ci sorregge ancora Piazza, che ravviso nella responsabilità del carisma profetico insito nella sua creatività a fronte della perdurante crisi illuministica.
La percezione acuta della crisi dell’illuminismo è, tra l’altro, un segno profondamente veneto. Un tratto che connota l’estetica di Piazza. Il quale racconta la propria terra e dunque la storia del proprio popolo.
La gente di queste parti ha grande senso pratico, una concretezza spesso decisiva, una laboriosità che rifugge dalle enfasi delle mode culturali imperanti. Il veneto tramanda valori, resiste alla marea dei cambiamenti. È pragmatico e antirivoluzionario.
Quando i dettami dei lumi francesi arrivarono da queste parti, sul finire del Settecento, trovarono ad accoglierli un popolo che già conosceva la tripartizione dei poteri, giustizia efficiente, sostanziale rispetto per le classi subalterne e politica attenta alle loro esigenze. Non attaccarono. O magari furono rimasticati e metabolizzati. Il buon senso dei Veneti li ha portati ad adattarsi e, al contempo, a non accettare di chinare il capo davanti al padrone. L’attaccamento alla terra -ieri- e il possesso personale dei mezzi di produzione -oggi-, sono la loro sigla esistenziale.
Piazza,veneziano di nascita e trevigiano di adozione, incarna appieno questa dimensione culturale.
I Veneti difficilmente sono radicali, estremisti. Hanno il senso del passaggio, del transito. Nel loro tessuto linguistico hanno eclissato il passato remoto e, anche per eventi lontanissimi nel tempo, usano il passato prossimo.
È troppo dire che nella poetica di Francesco Piazza tutto ciò è sedimentato e leggibile? Che l’opera grafica che ci accingiamo a presentare nella sua interezza è un possibile paradigma?
L’artista ritrae questo mondo e questa maniera di abitarvi e di essere, col disincanto di un osservatore che ne è partecipe e, al contempo, si sente abilitato a ricavarsi uno spazio di autonomia. Piazza osserva, narra, traduce, interpreta. Un po’ critica, un po’ condivide. Cioè manda in scena in modo poderoso e inarrestabile il ruolo del custode e del garante.
Il custode coltiva in sé mistero e miracolo. È pendolo che oscilla tra collaborazione creatrice e rivelazione trasmessa e proclamata. Anzi il tempo è scandito dalla parte della comunicazione, del destinatario.
Questo miracolo, questa collaborazione dell’uomo col suo dio, afferma, non può esistere se non è comunicabile e comunicata al prossimo. Può essere solo in quanto è partecipata. Ha in sé la ragione di esistere solo se è parte di un’armonia universale. La creazione artistica è di tutti gli uomini, anzi si colloca come componente del creato stesso, lode di Dio da parte dell’uomo.
Il richiamo perentorio all’armonia dell’universo.
Dramma e supplizio dell’uomo del Novecento.
La docile fibra di Giuseppe Ungaretti, il magma irrisolto e mistico di Mario Luzi, la stella variabile di Vittorio Sereni, le strade che corrono nella notte di Nelo Risi, la novella allegra di Camillo Sbarbaro, il male di vivere di Eugenio Montale. I pavesiani occhi della morte e il laico trasumanar pasoliniano. Con la terra desolata e gli uomini vuoti di Thomas Stearns Eliot, i volti nella folla di Ezra Pound, l’età dell’ansia di Wystan Hugh Auden.
È uno dei fuochi esplosivi di Francesco Piazza. Armonia conquistata con fatica, mai scontata, su una via lastricata di delusioni e paure.
L’armonia che si fa oggetto della ricerca, filtrata dal genio dell’artista e confezionata dalle sue mani, diviene dono. È ineluttabile, all’interno della poetica di Piazza.
Nel 1985 il quotidiano Il Gazzettino vara una iniziativa particolare. Chiama alcuni artisti veneti a dipingere una loro opera su una pagina del quotidiano stesso. A Piazza tocca l’11 marzo.
Ha l’idea: tira al torchio una propria incisione sul piombo del giornale (Alberi sul Montello, 1981, con didascalia Per quest’aria di libertà che vi corre tra i rami, vi dedico alla Polonia) con esiti di effetto e seduzione. Inchiostro su inchiostro, la pressione del torchio a mano dopo la pressione della rotativa.
Nell’intervista che accompagna l’incisione / foglio di giornale, chiarisce il senso del donare: ognuno deve fare i conti prima di tutto con se stesso, in sintonia con la propria coscienza. Dopo di che, quando egli realizza ciò che sente nella maniera più genuina, più pura e insomma contraria alla commercializzazione sfrenata, riuscirà a dare qualcosa di buono, a fare del proprio lavoro un dono.
Accade perché l’ispirazione artistica assume valore profetico nelle specie della responsabilità di aprire a tutti il frutto della creazione.
È una responsabilità invasiva. Opprime e magari lascia le ossa ammaccate.
Tuttavia attenua il proprio peso schiacciante e diventa lieve giogo, stimolo gratificante, passione entusiasmante allorché l’opera d’arte nasce per essere consegnata al prossimo come dono, come invito alla scoperta coinvolgente, come spinta a vedere e capire, come suggerimento a cogliere i beni gratuiti profusi nel creato e troppe volte celati da contingenze fatali. Questa sintonia dell’artista con l’universo che lo circonda è la forza dell’artista stesso.
Risultano evidenti le modalità di espressione di tale forza.
Un segno preciso, nitido, sicuro. Il nero filante sul nitore del supporto cartaceo.
In lotta dura con la materia stessa dell’incidere. In una conversazione con Giovanni Barbisan cui ha portato a vedere le sue ultime cose (la data è il 26 novembre 1977, Barbisan dice che nel paesaggio di Piazza gira un’aria da Canaletto), il vecchio maestro lamenta che lo zinco non sia più quello di una volta. Adesso ci mettono il cromo, afferma. E il rame? Il rame tradisce: mi si spacca il segno, quasi urla. Piazza condivide, in pieno accordo.
Una cura raffinata del particolare e del dettaglio in ogni parte dell’opera. Mai un tirar via, mai una approssimazione, mai una sbavatura o una superficialità.
Scrupolo e rigore che vigilano su estro e fantasia: Piazza li attinge da quella trattenuta ed elegante componente barocca che è propria del suo mondo poetico. Un barocco che si esprime (pensiamo a certe nature morte con i fiori) in un bulicare di forme sorvegliate ed essenziali, mai solo decorative o accademiche.
La lucidissima vaghezza di cui scrisse, a metà del Settecento, Antonio Maria Zanetti il Giovane parlando di Giambattista Tiepolo: suo distinto pregio è il pronto carattere d’inventare e inventando di distinguere e risolvere ad uno stesso tempo quantità di figure con novità di ritrovati, con molteplicità e ottima disposizione di attrecci e altro; unendo a ciò una esatta intelligenza di chiaroscuro ed una lucidissima vaghezza.
Su tutto, un senso totalizzante, perfino epico verrebbe da dire, della luce. Una sensibilità esasperata ed eccezionale. Protagonista e voce narrante: permea e intride, disegna territori, lascia intuire spazi ulteriori. Questo è il genio di Piazza. Questo il modo di porgere il dono.
Occorrono alla memoria alcuni paesaggi nevosi in cui sono proposti spazi di non-segno e tuttavia di densità estrema, giocati con intelligenza e gusto sui chiari e sugli scuri. Un valore grande, svincolato da una concezione meramente lirica della realtà e innervato piuttosto in un realismo all’interno del quale mai è possibile dimenticare che esiste il varco.
Cioè l’occasione, il passaggio, lo sguardo gettato oltre la materialità delle cose.
“Hai una luce che si sfregola”, ebbe a dirgli Giovanni Barbisan, con termine dialettale suggestivo ma introducibile: sfregolarsi vale sgretolarsi, cioè rompersi, essere friabile e sminuzzevole, quasi uno sfarinarsi , come suggerisce nel suo dizionario Giuseppe Boerio.
Boerio, che dedica un lungo lemma al termine, edita il Dizionario del dialetto veneziano nel 1829, quando, cioè, la gente di Venezia è ben consapevole che dopo Canaletto (che muore nel 1768) e Guardi (1793) non si può più guardare al paesaggio e al contesto urbano con gli stessi occhi di prima dell’avvento dei grandi vedutisti.
Della luce, forse, anche Boerio diceva che si sfregolava.
E insomma, dentro alla luce che si sfregola avviene la lieta e feconda scoperta del comunicare, dello spartire, del condividere. In ultima analisi, il segreto dell’ispirazione di Piazza.
Che viene innegabilmente dal mondo dove l’artista vive gioiosamente disponibile. Più egli è aperto agli altri e più si arricchisce dei beni degli altri, delle sensazioni che lo avvolgono e più ne sarà gratificato. Godrà delle caratteristiche della gente, del cielo che la sovrasta, della sua storia, della sua civiltà.
Senza porre domande. L’artista esiste e si propone. Sa che comunque riceverà più di quanto ha dato. Allora si offre: non si chiederà se il fruitore della sua opera abbia cultura o meno perché il rapporto sarà da cuore a cuore e la comprensione reciproca sarà totale perché basata sulla sincerità.
È evidente che questo è il sangue caldo di Francesco Piazza, il suo richiamo esistenziale, la tensione verso il sacro e il metafisico, consumata, assaporata, accettata in ogni fibra del corpo. Con generosità, senza contraccambi.
Piazza rievocava spesso alla fantasia dei suoi ascoltatori la gloriosa immagine del popolo di Siena che portò in trionfo la Maestà di Buonisegna senza dover ricorrere alla mediazione colta di qualche critico paludato per analizzarla e per dire che era opera stupendamente bella.
Quando, nel dicembre del 1991, la scuola media di Paese visita una sua mostra, una bambina lascia il suo commento.
L’opera che mi è piaciuta di più è stata “El Sie da Boscarato”. Rappresenta un luogo che ogni giorno posso ammirare perché ci abito vicino. E una sua compagna: il quadro che mi è piaciuto di più è”Il paradiso dello Storga” che mi dava un senso di pace perché a casa mia c’è sempre tanto baccano.
La riconoscibilità dell’opera d’arte da parte di ognuno, il rarefatto silenzio che evoca. Sintesi vigorosa e condivisibile.
L’estasi della bellezza raggiunta e posseduta. L’armonia con le altre creature dell’universo finalmente realizzata.
E il cilicio durissimo degli ultimi anni. La malattia e l’impossibilità di regalare ancora le proprie mani alla creazione.
Di recente (2006) i responsabili della Fondazione Feder Piazza hanno deciso di tirare al torchio (con quanta ansia è immaginabile: chissà se la lastra incompiuta avrebbe “tenuto”) l’acquaforte cui Francesco Piazza stava lavorando quando fu colto da un ictus devastante. Era il 25 settembre 1995.
L’ultima incisione di Francesco Piazza è attraversata da enigmi, a iniziare dalla citazione biblica apposta a didascalia.
Ha scelto, Piazza, il salmo in cui Davide riflette sulla sorte del giusto e dell’empio. Il silenzio davanti al dio è segno fisico (tattile, si potrebbe dire) della speranza in lui. Perché, dice il salmista, la giustizia del Signore darà secondo i meriti.
Piazza raccoglie, in didascalia, il monito al silenzio: Sta’ in silenzio davanti al Signore.
Una vera e propria poetica del silenzio. Presagio, profezia, esorcismo.
Piazza guarda gli alberi del giardino e intuisce, in sintesi assoluta. Un pioppo si staglia, superbo e solitario gigante. Un trionfo di foglie, un girarsi nella direzione del vento. Ha un’anima sospesa tra terra e spazi aperti. È una vita che racconta e confessa se stessa. Sorge in un tripudio di natura selvatica, da magma vegetale, ma è, in modo misterioso, appartato e isolato. Metafora di forte impatto evocativo. L’artista è consapevole che il fato incombe.
Così suggeriscono i rami che si dipartono e cercano autonomia, nodi che a un tratto si sciolgono e liberano energia creativa. Sono aurora e promessa. E tuttavia il loro intrico, il loro sparire, il loro ammantarsi di foglie sussurra che non tutto si può svelare. La vita può essere giustamente e consapevolmente votata all’attesa.
Spetta ai destini individuali conferire un senso all’attesa, coniugarla alla speranza.
E il silenzio che Piazza mutua dal salmista è la matrice profonda dell’attesa.
L’evangelista Giovanni avverte che in principio la parola era in Dio e che dunque l’uomo viene da un grande silenzio. Per dirla assieme a Paolo, quando scrive ai Romani, è l’attesa di una rivelazione del mistero tenuto nascosto per secoli eterni.
L’artista, si è detto, ha un gioco ampio nella rivelazione. Una sorta di mandato assoluto, testimoniato in modo struggente nell’incisione ultima.
Il silenzio è calato sul compito / ruolo di rivelazione.
La parte della lastra non lavorata da Piazza è quella superiore, il cielo.
Come non scorgervi il segnale estremo dell’attesa? Cui corrispondono i lunghi indugi sulla lastra dormiente.
Alla fine gli amici della Stamperia dell’Ariete hanno tirato Alberi in giardino- agosto 1995. Formidabile.
Solo l’inchiostratura e il torchio rivelano se una lastra regge davvero.
Tengono splendidamente gli alberi di Piazza. Rivelano, chiamano al silenzio.
Ammoniscono: il cilicio della sofferenza, l’estasi della rivelazione.
*
Pensieri, parole, riflessioni esplicitamente riferite a Francesco Piazza, ad Anna Maria Feder Piazza e ad altri (e segnalate dal corsivo) sono desunte da interventi dell’artista, da articoli e da lettere. Inoltre: da documenti dell’archivio della Fondazione Feder Piazza, da testimonianze di amici e conoscenti, da ricordi personali dell’autore del saggio.
Le foto sono state realizzate nella sede della FondazioneFeder Piazza di via dei Biscari alla vigilia della mostra che si è aperta il 29 settembre 2017 presso il museo Bailo di Treviso.