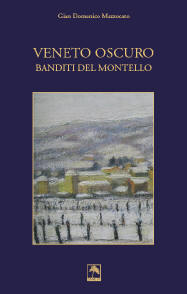 VENETO OSCURO
VENETO OSCURO
BANDITI DEL MONTELLO
Danilo Zanetti Editore (Per acquisti on-line www.libreriazanetti.it)
“La narrativa di Mazzocato dà la sensazione di essere dentro i grandi romanzi siciliani. Al tempo stesso il mondo veneto ne risulta portato al massimo di estensione e di completezza”. Così Fulvio Tomizza ha individuato il principale filone della narrativa di Gian Domenico Mazzocato che, sempre secondo la definizione dello scrittore di Umago, ha avuto il merito di delineare in questi anni una vera e propria “saga dei vinti veneti”.
Vinti in senso verghiano. Dalle pagine dello scrittore trevisano scaturisce una umanità dolente, l’umanità del profondo Veneto tra Ottocento e Novecento, quando pellagra e colera, ignoranza e miseria condizionavano la vita di un intero popolo. Un passato che la scrittura di Mazzocato rivela (dal suo primo, fortunato romanzo, IL DELITTO DELLA CONTESSA ONIGO, in poi) senza retorica, nella sua crudezza ed emozionante verità.
In questo volume vengono riunite due storie già narrate da Gian Domenico Mazzocato: 1909, DELITTO A FILÒ e IL RITORNO. (Il testo di entrambi è integralmente presente in questo sito). Ad esse l’autore premette una lunga, appassionante storia inedita, BANDITI DEL MONTELLO.
Tre romanzi che raccontano eventi dimenticati ma che, tra il 1890 e il 1910, ebbero nel Veneto una risonanza enorme. Tre vicende umanissime, tre ampie inchieste storiche e sociali, tre fatti raccontati in presa diretta, con la verve del grande romanzo e l’incalzante interesse della cronaca.
In particolare, BANDITI DEL MONTELLO racconta quello che dovette sembrare ai contemporanei il colpo del secolo: per entità del bottino, per il terribile delitto che ne scaturì, per il suo amplificarsi nella fantasia popolare, per il fluviale processo in cui furono giudicati i colpevoli, per la diffusa consapevolezza che anche altri avevano partecipato al colpo e che probabilmente il “cervello” dell’operazione rimaneva nel buio.
Mazzocato racconta questo suo VENETO OSCURO con la forza coinvolgente che solo i grandi romanzi possiedono.
FU IL COLPO DEL SECOLO
Ecco le pagine iniziali di BANDITI DEL MONTELLO in cui si traccia il quadro all’interno del quale si svolge la vicenda.
Qualcuno lo cerca ancora l’oro di Bicio Soligo, tra i roveri e le fargne del Montello.
In qualche anfratto, in una forra o in un pozzo, oppure in un vallone, dove è più rigoglioso l’intrico delle sterpaglie. Vicino al Forame da cui zampilla la Giavera, proprio sotto la vecchia chiesa del paese.
O dalla parte opposta del monte, nel Buoro di Ciano, dove le puerpere vanno a bere l’acqua sacra e a pregare san Mamante di gonfiare i loro seni di latte denso e vigoroso, o magari tra le rovine della certosa antica dove dormono i frati che per secoli hanno abitato la collina. Forse in qualche nicchia della grotta di san Girolamo in \cui nelle notti di luna piena torna l’anima degli eremiti che vi hanno trascorso la loro vita solitaria.
Faustino “Bicio” Soligo, un imputato tra i tanti in quel lontano processo celebrato in Corte d’assise a Treviso, tra il gennaio e il febbraio del 1888. Una Treviso povera, dissanguata dall’emigrazione, preoccupata dal colera alle porte.
Ai margini del progresso. Solo il 3 ottobre 1886, una domenica, in piazza dei Signori si inaugura il servizio a un primo, sparuto gruppo di abbonati telefonici. I concessionari del servizio, Salvuzzi e Arcani, aprono, a chi lo vuole visitare, l’ufficio centrale di piazza dei Signori. I primi abbonati sono in tutto 12. Tra di loro la prefettura, le guardie municipali, il cavalier Giovanni Appiani, la tipografia Longo e un commerciante di vini, Provera. La luce elettrica è riservata alle città e si raccolgono le adesioni dei privati per comperare le lampade elettriche, cinque lire l’una. A Treviso si spera di raggiungere la quota di 500 lampadine.
Proprio in quel 1886, nella notte tra il 27 e il 28 aprile, una banda di ladri svaligiò, a Solighetto, il palazzotto del conte Guido Brandolin. Solighetto è un villaggio di poche case, a nordest del Montello, sulla strada che da Pieve, costeggiando il Soligo, va verso Follina.
I banditi asportarono una cassaforte pesantissima e realizzarono la più imponente refurtiva di cui mai si fosse avuta notizia: vicenda terribile e dolorosa, che aveva radici nella miseria e nell’ignoranza indotte dal secolare esilio delle genti montelliane dalla loro collina.
Più di quattro secoli erano trascorsi dal nevoso natale del 1471, quando il doge Nicolò Tron bandì il Montello alla gente che da millenni abitava la collina, destinando per sempre la ricchezza immensa del bosco, i suoi alberi, agli squeri e agli arsenali della Serenissima.
Il Montello sarebbe tornato alla sua gente pochi anni dopo il processo, il 21 febbraio 1892, quando re Umberto firmò la legge che, vincendo durissime resistenze, Pietro Bertolini aveva fatto approvare. E tuttavia i Montelliani, quando ripresero possesso della loro collina, 421 anni dopo esserne stati esiliati, trovarono un mondo distrutto e impoverito di ogni risorsa. Non recò il miracolo di una improvvisa ricchezza, il ritorno sul Montello.
Nei secoli le genti montelliane avevano vissuto una diaspora irreversibile. Il popolo che abitava alle falde del Montello e viveva di espedienti, di furtarelli, di commercio illegale del legname strappato con grave rischio alla collina, scontava una condanna perenne alla povertà e all’ignoranza, al malessere e al disagio.
Le statistiche dell’emigrazione, per lo più verso il mato brasiliano e le pampas argentine, indicano cifre altissime: i paesi si svuotavano per riempire la terza e la quarta classe dei vapori che incessantemente varcavano l’oceano tra i due continenti con il loro carico di disperazione.
Ai primi di marzo del 1887 passa per la stazione di Treviso un treno carico di settecento emigranti del territorio di Oderzo. Vanno in Brasile. I procacciatori di braccia hanno promesso viaggio gratuito e trenta lire di premio per ogni famiglia che accetta di partire intera. Stiperanno 18 carrozzoni ferroviari nel loro viaggio fino a Genova, il porto d’imbarco. Da Levada a Ponte di Piave i migranti sono accompagnati da una banda musicale che “rallegra i loro ultimi momenti di permanenza nei luoghi natii”, come scrive la cronaca della Gazzetta di Treviso.
I giornali di tanto in tanto pubblicano qualche lista di nomi ripresa da fogli brasiliani avventurosamente giunti in redazione e spesso è l’unico modo in cui si viene a sapere che il fratello partito un anno prima o i cugini assenti ormai da dieci anni vivono in quel certo distretto brasiliano, in quella certa provincia. Formano dei nuclei, come si dice: i nomi sono quasi sempre brasilianizzati. Tommaso diventa Thomaz, Giuseppina ora si chiama Josephina. E perfino i cognomi: Mazzocato arrotonda la durezza delle zeta in Massocatto.
Qualche volta si fa sentire sulle colonne dei giornali la voce dei grandi agrari preoccupati per il continuo venir meno della manodopera. Soprattutto se ne vanno i mezzadri “sedotti dagli agenti di emigrazione”, ma è alto (e allarma!) anche il numero dei piccoli possidenti.
Mai un rigo per dire che i contadini affrontano l’ignoto perché non hanno proprio nulla da perdere. In compenso i giornali pubblicano con cadenza quasi giornaliera notizie tragiche sulle condizioni di vita in America Latina. Lo scopo è incutere terrore in chi sta progettando di imbarcarsi, di distogliere dal proposito. Notizie di disagi reali, di condizioni oggettivamente disumane vengono scientemente ingigantite.
Gli Italiani, si legge, vanno in Brasile a sostituire gli schiavi dopo l’abolizione della schiavitù. E gli emigrati vengono trasferiti da una zona all’altra di quel paese immenso senza preavviso e senza loro consenso. Famiglie intere supplicano re Umberto di concedere loro il biglietto di rimpatrio gratuito. La febbre gialla miete vittime tra gli immigrati ammassati come bestie sul molo di Porto Alegre e in attesa di un collocamento. L’Argentina sta pianificando la politica di sviluppo ferroviario e recluta duemila operai in Italia: essi saranno almeno per un anno “in balia dell’impresa” appaltatrice dei lavori, scrivono i giornali. Se qualcuno vuole andarci ugualmente, sappia che il lavoro si trova comunque con difficoltà estrema e i beni di primo consumo sono soggetti a vertiginosi aumenti di prezzo: un chilo di pasta passa in poche ore da una lira a due lire e mezza. La conseguenza è che il paese è in preda agli scioperi. E in Cile “per questioni di razza e lingua” gli Italiani sono discriminati e “languono”.
Giornali, ma anche libri. L’editore Treves pubblica, nel marzo del 1889, Sull’Oceano. Edmondo De Amicis vi descrive l’orrore che si vive, da Genova a Montevideo, durante i trenta giorni di viaggio da parte dei 1500 migranti imbarcati nella terza classe del Galileo.
Eppure i vapori sono sempre pieni e gli agenti procacciatori fanno affari d’oro, anche se nel marzo del 1889 un decreto del ministero dell’interno inibisce la loro attività. Naturalmente non smettono, continuano sottobanco. Florio e Rubattino continuano a reclamizzare su tutti i giornali le loro linee per Montevideo e Buenos Aires, anche se avvertono che le partenze per Rio de Janeiro e Santos sono sospese per decreto ministeriale.
Il malessere sociale è diffuso. Nel febbraio del 1887 mille operai, impegnati in lavori idraulici a Motta di Livenza, incrociano le braccia. Intervengono i bersaglieri. E l’esercito interviene anche a Treviso per sedare i tumulti scoppiati nelle carceri criminali di piazza Duomo: il pane dei detenuti è immangiabile. Per sedare la sommossa bisogna far uso delle celle di rigore.
Dal meridione è sbarcato a Venezia, proprio nei giorni del furto Brandolin, il colera: si registrano decine di nuovi casi al giorno, migliaia nella sola provincia di Treviso. Denutrizione, pellagra, pessime condizioni igieniche hanno spianato la strada e la malattia miete vittime. La mortalità è altissima: ogni due persone che contraggono il colera, una muore.
Ma è attorno al Montello che il colera infuria nel modo più terribile e virulento. Qui decine di persone vivono ammucchiate come bestie in casupole miserabili.
Scrive un cronista nei giorni più terribili del morbo: “La piaga dei poveri boscaioli che vivono intanati, affollati nei meschini tuguri che contornano il bosco, è divenuta orribile cancrena. Ben sapevamo che c’era della miseria, credevamo anzi che ad essa fosse dato largo tributo dal vizio e dall’ignavia: ma non credevamo in un male così profondo, in un dolore giunto a tal grado”.
A Giavera, in una casa colonica, cinque famiglie vivono ammassate in poche stanze. Il contagio le devasta. Muore un bambino di cinque anni e in poche ore anche sua madre. Il padre, Bepi Volpato, sta tirando gli ultimi su un miserabile pagliericcio e si vede passare davanti i cadaveri della moglie e del figlio.
Angelo Marchiori (è soprannominato Morte, quasi il destino volesse farsi beffe di lui) vive in una stamberga di due stanze e cucina. È in agonia, sul giaciglio vicino al suo sta morendo un figlio, altri figli sono riversi su giacigli improvvisati. Gli infermieri, per portare via la moglie morta da poche ore, devono camminare sopra di lui.
Per i sopravvissuti il quadro è, se possibile, ancor più penoso. Il cronista ha un moto di pietà perfino per chi vive di furti: “I guariti ischeletriti dal male e dall’inedia offrono uno spettacolo non meno compassionevole dei malati. Come potranno essi il prossimo inverno fare i 12 o 14 chilometri necessari per raggiungere il bosco e portarsi via un fascio di legna che venderanno poi per 60 centesimi se riusciranno ad eludere la vigilanza dei carabinieri?”. Proprio queste cronache aiuteranno Bertolini a risolvere con una legge la questione del Montello che per decenni era stata perfino irrisa dal parlamento italiano.
La zona montelliana è il ventre molle del Veneto. Qui problemi migratori e problemi sanitari si saldano. Sui Montelliani, già stremati dal colera, si abbatté una malattia importata da emigranti di ritorno dall’America e sbarcati a Genova, il vaiolo. I primi ammalati furono ricoverati a metà di maggio del 1889 nel lazzaretto di Volpago.
I Montelliani erano, nella diceria comune, un popolo di ladri. I Montelliani nascevano ladri.
Al processo Brandolin il pubblico ministero Cisotti evocherà l’immagine del bosco Montello come quella di una “prospera terra che avrebbe dovuto essere rispettata da tutti”. E tuttavia “una popolazione raminga, passato il Piave, facendosi ladra di professione, devastò tanta bellezza”.
Più di 21 mesi tra il furto di Solighetto e la sentenza, un delitto mai del tutto chiarito durante la spartizione del bottino, 17 imputati fra cui due donne, quasi tutti condannati. Cinque furono le condanne ai lavori forzati a vita. Agli altri imputati furono inflitte decine di anni di lavori forzati, di reclusione, di libertà vigilata. L’aula della Corte d’assise di via Canova fu gremita di gente di tutte le condizioni sociali, il pisnente accanto al nobile, in ogni giorno e in ogni ora del processo. Le gazzette aumentarono le tirature, gli stenografi delle diverse redazioni si davano in continuazione il cambio. La fantasia popolare arricchì l’evento di elementi fantastici.
Le condanne furono pesanti. Ma probabilmente il cervello dell’operazione non era tra gli imputati. E tanti furono gli interrogativi che il processo non chiarì. Soprattutto non risolse l’enigma di fondo: chi aveva dato l’avvio al colpo? Il bottino fu recuperato solo in parte.
Il pubblico ministero Cisotti chiuderà la sua arringa parlando di bande di malfattori inevitabilmente sorte attorno al Montello, proclamando una verità indiscutibile agli occhi dei più: “divenuti ladri di legna divennero ladri di tutto”.
Faustino Soligo faceva parte di una di quelle bande. Esisteva una manovalanza criminale costituita da persone che conducevano quasi sempre una vita apparentemente normale. Si conoscevano un po’ tutti, si aggregavano all’occorrenza, facevano gruppo, diventavano banda attorno al progetto di un colpo.
La banda di Soligo non era certo la meglio organizzata ma probabilmente la più numerosa, quella che mise a segno il colpo più clamoroso. Del processo che seguì non è traccia alcuna nella memoria della gente veneta. Eppure fu tragico blasone, un emblema della storia di quegli anni.
Ora la vicenda riemerge e il merito spetta ad un quaderno sgualcito, rinvenuto nel retrobottega di un robivecchi, tra scatoloni di carte polverose. Un caso, una fortuna. Manca la copertina e l’autore è destinato a restare anonimo. Una grafia minuta, regolare, che occupa ogni spazio, meticolosa. Uno scrivere sensibile, uno scrivere di donna, verrebbe da dire. E la lettura corre sotto gli occhi veloce: colta, disincantata, acuta, a tratti pungente e ironica
L’autore viveva a Treviso, ne respirava gli umori. Leggeva i giornali, ascoltava le ciacole della gente. Certo non mancò ad alcuna delle udienze processuali. Fu colpito soprattutto dal gran nome del derubato, Guido dei conti Brandolin, dai misteri mai risolti dall’inchiesta, dalle dicerie corse tra la gente. E naturalmente dall’enormità del bottino.
Una refurtiva immensa contenuta in una poderosa cassaforte austriaca incassata nel muro, una Wertheim del 1860: “I valori erano 12 cartelle di rendita italiane di lire mille ognuna il che forma un importo capitalizzato realizzabile ai corsi di giornata di circa lire 230mila più 500 napoleoni d’oro (10mila lire) più gioie, argenterie ecc. (10mila lire) per un totale di 250mila lire”, riesce a computare il cronista del tempo sulle colonne delle gazzette.
250mila lire, una cifra enorme. Il conte Guido Brandolin fornisce ai giornali i numeri di serie delle cartelle di rendita e promette la somma di 5mila lire a chi darà indicazioni utili per recuperarle. Anche 5mila lire (un nulla, peraltro, a confronto dell’entità del bottino) possono cambiare una vita. I Brandolin sono una potenza, una grande famiglia nobiliare diramata tra Veneto e Friuli. Annibale, fratello di Guido e gentiluomo di corte, possiede il magnifico castello di Cison di Valmarino, un altro Brandolin è vescovo a Ceneda, un altro ancora ha terre immense e villa a San Cassan di Meschio.