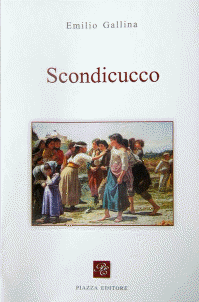 Scondicucco
Scondicucco
(di Emilio Gallina, Piazza Editore)
Emilio Gallina sta, da anni, lavorando ad un progetto che, agli occhi di chi legge e ama la sua poesia, va assumendo contorni sempre più precisi, fa risaltare dettagli e particolari.
È un lavoro, come dire?, territoriale: Gallina sta delimitando i confini del suo piccolo mondo antico letto in chiave trevigiana. Sta piantando i paletti, si guarda attorno, si porta bonariamente una mano sulla fronte per difendersi gli occhi da qualche spièra de sol, esplora con la sua sensibilità robusta anche per tutti noi, suoi concittadini e suoi conterranei.
Continua ad esplorare, con indagine acuta e cattivante, anche in questa sua silloge che intitola, per gentile provocazione, Scondicuco.
In premessa sente di dover spiegare al lettore. Ha scelto la parola bellissima (evocatrice, misteriosa, magmatica come nessuna traduzione in lingua colta potrà mai essere) che corrisponde all’italiano nascondino perché il poeta ama nascondersi dietro le sue immagini, giocare ad esserci e a non esserci tra un verso e l’altro, rimbalzando da una strofa alla strofa successiva.
Naturalmente, siccome gioca a nascondersi, il poeta non rivela tutte le regole del gioco stesso. Non può farlo, perché ogni scrittura è una scommessa. Lo scrittore è obbligato a scommettere sull’intelligenza, sulla sensibilità del suo lettore. Deve scommettere anche sul fatto che il lettore, portatore di una sua ricchezza intellettuale, vi trovi qualcosa che il poeta stesso non sapeva di avervi celato. Quando questo miracolo si verifica, la sorgente è pura, l’acqua sgorga limpidissima, la strada del rivo si trasforma presto in fiume possente.
Allora, sulla base della sua onestà culturale, Gallina sa bene cosa deve fare. Deve intanto stabilire il codice di comunicazione.
Lo fa giocando e celandolo fino alla fine: è pur sempre uno (uno? o un come vorrebbe l’articolo dialettale?) scondicuco, no?
Nell’ultima lirica di questa silloge, chiede, o meglio proclama, ’Asseme parlàr in diaéto.
Una sorta di manifesto della lingua “altra”. Non è, ricorda Gallina, la parlata utile a dipingere macchiette e caricature umane ad opera dei luoghi comuni massmediatici. È la parlata che disegna i confini di una più ristretta area geografica (viene in mente il titolo di un’altra silloge di Gallina: ‘A me tèra ‘a me zénte), un ambito più intimo e domestico, la necessità di una comunicazione diretta e immediata con chi quel codice condivide.
(Vale la pena di rimarcare impegno e rigore con cui Gallina si pone il problema. L’apparato delle note è particolarmente calibrato e curato. E si segnala anche l’appendice molto densa del glossario di cui, diciamolo con franchezza, ha bisogno anche il lettore più smaliziato, quello che ha il dialetto come prima lingua naturale, appresa dai genitori, nell’oralità quotidiana. Perché questa è la ricchezza straordinaria del dialetto: anche solo rimanendo entro le mura cittadine ci sono differenze di lessico e pronuncia tra una zona e l’altra. Ricordo bene che io, nato sopra l’osteria Ai Due Mori in via Palestro, notavo qualche differenza con i cugini materni che abitavano nella vicinissima piazza Rinaldi. Per non dire dei cugini da parte di papà che stavano vicino alla Madonna Ausiliatrice -dai frati, come si diceva e come penso si dica ancora- e parlavano una lingua marcatamente diversa, soprattutto a livello gergale. Sottolineo tutto questo per evidenziare anche il valore strettamente documentario del lavoro di uno scrittore attento come Gallina.)
Tuttavia non basta la lingua come tale, come strumento astratto: questa sarebbe operazione di una nostalgia dei tempi andati che fin troppi danni ha fatto.
Bisogna, se posso dire così, stendere sopra il tessuto linguistico la teoria degli oggetti, dei luoghi, degli eventi, delle situazioni che proprio grazie a quella lingua trovano la loro più compiuta espressione.
Eccolo il lavoro di Gallina, eccolo il suo piccolo mondo antico. Testimoniato da dentro, con partecipazione assoluta, con affetto filtrato dall’ironia. Eccolo piantare i paletti, disegnare i confini.
Confini mutevoli, come si intuisce, mediati dalla memoria e dall’esperienza, innervati dalla volontà di riproporne l’attualità.
Devo chiarire che, sotto la lente del critico, appare chiaro come Gallina abbia un suo cliché espositivo, una consolidata struttura scritturale. Moltissime delle sue liriche partono da una annotazione sensoriale, qualcosa che colpisce profondamente (o improvvisamente o inaspettatamente, decida il lettore di volta in volta) la vista o l’udito o magari il tatto. Gallina focalizza, se serve, questa sensazione nel titolo. Poi ci lavora sopra, ci gioca, riflette, si fa prendere dal suo stesso materiale espressivo.
Devo citare? Mi limito ad esemplificare: Mace de inchiostro, “…e pu!” (col suo esordio Vardàvo, Cristina), Marendìn (col suo strillo iniziale “Mama gò fame!” e con quella bella culminazione che fa sentire al lettore ‘na scampaneàda/ da tirar zò ‘a casa).
Colpisce, in questo lavorare di Gallina su materiale quotidiano attinto tra memoria e cronaca, la capacità di dare vita ad una immagine, facendone il perno attorno al quale gioca e ruota tutta una situazione sentimentale, evocata con precisione di contorni. Una lirica su tutte, in questo senso: Risi e bisi e un vénare santo. Quel piatto, così comune sulle tavole venete, è piatto per molti anni messo al bando dalla tavola di Emilio Gallina.
Perché? Perché era imbandito sulla tavola al tèrso piano/de via Carlo Alberto a Treviso il 7 aprile del 1944, quando l’inferno sembrò rovesciarsi sulla città e aprirsi sotto i piedi dei cittadini. Il piatto diventa il simbolo inatteso, strano e perfino paradossale nel suo minimalismo (e dunque proprio in virtù di ciò verissimo), di una tragedia immane. Verrebbe proprio da dire: la morte aveva il gusto e l’odore di quel piatto.
Per quella persona che allora era bambino ed ora è poeta che tra-scrive e ricorda. E per nessun altro. Perché è la vita stessa che si diverte a mescolare cose lontanissime tra loro: un piatto di risi e bisi e una angoscia inimmaginabile. E la poesia è, per sua stessa scelta, riflesso e lettura della vita.
Oppure si vada a leggere Scondicuco, la lirica eponima. Bellissima: il nascondersi allude all’affiorante sessualità adolescenziale, al gioco dei sentimenti che sgorgano inattesi e nuovi, con un senso esplicito di una scoperta della propria dimensione interiore.
Ancora. Il nucleo di liriche incentrate sulla figura materna. Trovo straordinaria la situazione in cui il poeta si interroga su chi avrà il coraggio di portare ad una mamma la notizia che il figlio tredicenne è rimasto sull’asfalto (Chi ghe dirà a to mama).
Oppure le liriche che rievocano luoghi (paesi o luoghi più circoscritti, come la montelliana Presa Dieci o il portico dei Buranelli).
Trovo poi esemplare una lirica come Cante de Nadàl. Anche qui il venir meno di un suono, il disperdersi nell’aria di una nota musicale (El coro gà péna finio…) che in realtà non è fine. È piuttosto l’inizio di un viaggio nella memoria e con la memoria. La poesia di Gallina si connota anche di questo: della sensazione della labilità del tempo e della fragilità delle cose umane.
Provo la tentazione di raccontarlo ancora a lungo, io, il mondo piccolo di Gallina, in esso coinvolto e quasi impaniato. Ma è giusto che sia scoperta di ogni singolo lettore. Che non mancherà certo a questa ulteriore prova del poeta trevisano.
Perché, se il tempo è labile e le cose umane sono fragili, serve il filo d’Arianna che può sgomitolare un poeta per districarsi nel labirinto della quotidiana avventura esistenziale.
GIAN DOMENICO MAZZOCATO
(Treviso, 24 maggio 2004)