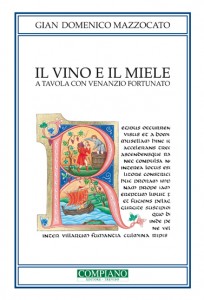Il vino e il miele
A tavola con Venanzio
Biografia “non autorizzata” di un grande trevigiano
Compiano Editore, Treviso 2011
SOMMARIO
VENANZIO, IL PARADOSSO
IL VINO E IL MIELE / IN VIAGGIO CON VENANZIO
ANTOLOGIA DEI CARMINA
ANTOLOGIA DELLA VITA DI SAN MARTINO
CRONOLOGIA DELLA VITA DI VENANZIO FORTUNATO
IL SECOLO DI VENANZIO
(LE BATTAGLIE DI RE ARTÙ
E I DISASTRI DELLA GUERRA GRECO-GOTICA)
“…il vino: qui i sassi lo generano e lo fanno scorrere”.
(Venanzio Fortunato, Carmina X, 9, Il viaggio in battello)
“Le opere dei secoli successivi si facevano più rare nella biblioteca di Des Esseintes. Il VI secolo era ancora rappresentato da Fortunato, vescovo di Poitiers, di cui gli inni e il Vexilla regis, tagliati nella vecchia carogna della lingua latina, speziata con gli aromi della Chiesa, lo ossessionavano in certi giorni”.
(Joris-Karl Huysmans, À rebours)
“Ingegno luminoso, sensibilità attenta, eloquio dolcissimo: infinite pagine ne riecheggiano la dolce melodia: Fortunato, culmine della poesia, venerabile nel suo agire, generato dalla terra d’Ausonia e qui sepolto. Dalla sua bocca divina apprendiamo le gesta degli antichi santi: essi ci indicano il cammino della luce.
Felice tu, o Gallia, adorna di così preziosi gioielli: la loro luce fuga il buio della notte. Versi miei, di un povero poeta, e scritti con metro plebeo:ma non volevo, o santo, che il popoli dimenticassero la tua gloria”.
(Paolo Diacono, Storia dei Longobardi, II, 13)
“… la splendida vite rosseggia sul candore della petraia…”.
(Venanzio Fortunato, Carmina X, 9, Il viaggio in battello)
“E allora sarò io degno di porre mano alle gesta del beato Martino, generato dalla Pannonia, in cui risplende la luminosa Sabaria, e di raccontarle con la mia lingua balbuziente? Martino non ha certo bisogno delle mie oscurità, lui che brilla di luce folgorante, un faro che splende alto nelle Gallie e che spinge la sua luce fino all’India”.
(Venanzio Fortunato, Vita di san Martino, I, 45-49)
Pampini intrecciati e un uccello che prende vita sotto un tralcio:
graziosamente col becco assaggia dipinte vivande.
Il convitato ben meritò di godere un copioso banchetto:
ecco l’uva sotto i suoi occhi e intanto beve vino di Falerno.
(Venanzio Fortunato, Carmina III, 13c,
Parole su un quadro raffigurante una vite, alla tavola di Villico )
Su queste colline sterili, Nicezio
ha piantato uve che recano dolci succhi
e, dove prima era boscaglia incolta,
ora è vigna ben lavorata.
(Venanzio Fortunato, Carmina III, 12,
Il castello di Nicezio sulla Mosella)
IL POETA DELLA FERTILITÀ
Il poeta della fertilità.
Venanzio Fortunato è stato definito in molti modi: poeta dei fiumi, poeta dell’esilio, poeta dell’amicizia, poeta della nostalgia.
In questo saggio, scritto con lo stile rapido del romanzo, Gian Domenico Mazzocato esplora la vita dell’ultimo grande poeta latino nel segno della fecondità che trova i suoi simboli nel vino e nel miele.
Una biografia ampia. Il dramma di un uomo che ha lasciato la sua patria (Valdobbiadene, sulle rive del Piave, nelle prealpi trevisane) e non vi ha mai fatto ritorno.
Venanzio ha conosciuto i potenti della emergente nazione franca e ne ha influenzato la politica. È stato maestro di eleganza e cultura, ponte e sintesi tra la classicità latina, la cultura cristiana e l’aristocrazia merovingia che avrebbe dominato l’Europa
Ma Venanzio qui viene indagato anche nel suo quotidiano.
La vigna, i pampini, l’uva, il favo del miele diventano paradigmi di una parabola esistenziale che è stata inquieta ma anche fertile di gratificazioni e riconoscimenti.
Un contributo importante alla conoscenza di un protagonista dell’Europa di allora.
Che fu soprattutto straordinario cronista ed entusiasta interprete del suo tempo.
La vita di Venanzio non fu facile ma venne da lui vissuta con gioiosa e ironica intelligenza.
Di essa si potrebbe dire quello che il poeta ebbe a scrivere di Nicezio, vescovo di Treviri: “Su queste colline sterili Nicezio ha piantato uve che recano dolci succhi e, dove prima era boscaglia incolta, ora è vigna ben lavorata” (Carmina, III, 12).
DALLA PREFAZIONE
NEMMENO I SANTI…
Nemmeno i santi disdegnano la buona tavola.
Non si sottrae alla regola Venanzio Onorio Clemenziano Fortunato, nato a Valdobbiadene, tra le prealpi venete, attorno al 535.
Una vita da esule, avventurosa la sua buona parte. Laico dalle molte relazioni, poi prete e vescovo in Poitiers.
La Chiesa lo ricorda tra i suoi santi il 14 di dicembre, giorno in cui morì, nel 603.
Dunque i santi mangiano e bevono, anche se con cristiana misura.
Kaspar Brandner, l’estroso e umorale personaggio creato nel 1871 da Franz von Kobell e portato in teatro da Joseph Maria Lutz, quando arriva in paradiso dopo aver eluso a lungo la nera signora battendola a carte e ubriacandola, non può credere ai suoi occhi.
È davvero per evitare quel posto che ha lottato, è il caso di dirlo, fino all’ultimo? Lì i bicchieri di birra si riempiono da soli e i santi mangiano salsicce. E una partitina a carte mentre si digerisce è di fatto obbligatoria.
I santi e il cibo, che rapporto sorprendente.
In Sicilia, al ricorrere della festa di san Giuseppe, da Monreale alla agrigentina Alessandria della Rocca, le famiglie gareggiano nell’imbandire gli altari. Veri monumenti culinari che poi finiranno sulle tavole delle persone più povere.
A giudicare dai manuali di cucina i santi preferiscono i dolci.
Dalla torta di san Pietro alla cuccìa di santa Lucia, dalla sfincia e dalle zeppole di san Giuseppe alle lacrime di sant’Anna, dalle dita degli Apostoli alla pitta (che bel nome latino, una focaccia picta) della Madonna e agli uccelletti di sant’Antonio c’è di che ridisegnare la geografia del nostro paese e riscrivere qualche buon libro di agiografia.
Dolci, ma anche sostanziosi primi piatti se è vero che vicino a Roma c’è la sagra delle cannacce di sant’Apollonia. Le cannacce sono una soda pasta di segale da cucinarsi con pomodoro, basilico e timo. Tanto per non negarsi il favore di un’aureola (non si sa mai) qualcuno le chiama anche cannacce di sant’Anatolia.
Beh, e che diciamo delle ultime cene sparse in tutta Europa? Sì, voglio dire proprio la cena di Gesù e dei suoi dodici amici (facciamo undici, il dodicesimo, Giuda, non aveva gran pensieri per la testa). Un elenco lungo come un menù di nozze.
Leonardo, Tintoretto, Giovanni Canavesio, Duccio da Buoninsegna, Jean Huguet hanno imbandito tavole per ogni gusto: sobrie, ricche, parsimoniose, perfino sfacciate. Chi non ha proprio il senso della misura è l’anonimo scultore delle statue in legno dell’ultima cena che si trova in una cappella del Sacro Monte di Varallo. Non si nega nulla, da sfamare un esercito.
E quando i gamberi rossi abitavano i nostri fiumi, dalle acque, allora limpide, dei corsi d’acqua hanno invaso le tavole sulle quali Gesù ha consacrato il pane e il vino.
Il santuario dei santi Vittore e Corona a Feltre, la chiesa di san Giorgio nel veneziano sestiere di San Polo, la chiesa di santo Stefano a Carisolo, la chiesa di sant’Antonio Abate a Pelago (dove hanno lavorato i Baschenis, la famosa dinastia di pittori bergamaschi), l’oratorio della Natività di Maria a Cadessino di Oggebbio.
E poi i gamberi più famosi. Quelli dell’ultima cena della chiesa di san Giorgio di Ormelle in provincia di Treviso. Gli apostoli accompagnano alla squisita vivanda qualche bottiglia di vino color rubino. Ma non manca nemmeno la trasparenza di una bottiglia di bianco.
Qui vicino scorre il Piave e poco più in là il Sile.
Proprio in riva al placido fiume di risorgiva che attraversa Treviso, uno straordinario pittore, Luigi Rincicotti, popola il suo universo di santi e angeli mangiatori.
Per dire che la santità senza la corporeità non è molto credibile.
Lo stesso frugale san Martino si concedeva un lusso a Pasqua. I suoi discepoli, conoscendone i gusti, gli imbandivano un pesce catturato nelle acque della vicina Loira. E lui non sapeva dire di no.
San Martino, proprio il santo raccontato da Venanzio Fortunato.
Leggendo i suoi Carmina salta agli occhi il paradosso di questo uomo dalla vita straordinaria, il primo delle sue terre a diventare personaggio di rilievo europeo.
Di lui sappiamo tutto e non sappiamo nulla.
Non abbiamo risposta alle grandi domande della sua esistenza.
Davvero Valdobbiadene è il suo luogo di nascita? O è nato a Ceneda come sostiene qualcuno? Quali sono stati i suoi studi e i suoi maestri? Perché ha lasciato la sua terra? E soprattutto perché non vi ha mai fatto ritorno?
In compenso conosciamo tutto delle sue relazioni umane, dei suoi gusti, della sua vita quotidiana.
Il suo rapporto col cibo e col bere.
Lo abbiamo seguito nei momenti chiave della sua esistenza.
Ci siamo seduti a tavola con lui.
Abbiamo conosciuto i suoi amici. Abbiamo cercato di non farci coinvolgere in qualche solenne bevuta in cui la stanza del convivio diventava, negli effluvi vinosi, un mare in tempesta. E il tavolo imbandito l’unica zattera cui aggrapparsi.
È nata qui l’idea di questa “biografia non autorizzata”.
DALLA PRIMA PARTE
VENANZIO, IL PARADOSSO
Valdobbiadene o Ceneda?
A Ravenna per curare i suoi occhi
Alboino era sceso dal Balaton seguendo l’antica strada romana che collegava l’Italia alla Pannonia. Ce lo racconta Paolo Diacono nella sua monumentale Historia Langobardorum. E nello stesso contesto Paolo Diacono, citando espressamente come propria fonte il IV libro della Vita sancti Martini, ci riferisce la cecità di Venanzio e Felice, guarita davanti all’altare ravennate di san Martino.
Nel suo complesso, il racconto di Venanzio, non sembra lasciar che pochi margini di incertezza, tutti a favore di Valdobbiadene e contro Ceneda.
Ma ad essere decisivo è proprio quel passo di Paolo Diacono. Egli, di fatto riassumendo e parafrasando, la parte finale della Vita sancti Martini dimostra di non avere dubbi sulla nascita valdobbiadenese di Venanzio. Paolo Diacono scrive il suo capolavoro storiografico tra il 787 e il 789, “appena” due secoli dopo la Vita sancti Martini.
Torniamo anche noi a Ravenna, dunque.
Siamo nella tuttora esistente chiesa di Giovanni e Paolo, attorno al 560. Accanto a Venanzio è Felice. L’episodio che lo vedrà contrapposto ad Alboino è di pochi anni posteriore (568).
Quell’evento è, seppure in modo velato, indicato all’esordio della narrazione dell’avventura esistenziale di san Martino. “È dunque una ragione importantissima a indurmi a tessere il panegirico del vescovo che è stato all’origine della mia venuta in questo paese”, annuncia Venanzio Fortunato nei versi proemiali della sua opera. Quale sia la ragione importantissima è enigma che, come abbiamo visto, scioglierà negli ultimi versi.
Dunque un nodo esistenziale fortissimo lega Venanzio e Martino. Perché il primo ha ricevuto dal secondo un miracolo immenso, la luce degli occhi.
Ormai praticamente cieco, compie l’atto abbastanza inspiegabile di ungersi gli occhi con l’olio di una lampada votiva. E torna a vivere, torna a vedere.
Se scrive di Martino con tanta ampiezza, se impegna fino alle più strenue risorse la sua abilità poetica, se sceglie la strada difficile dell’esametro là dove tutte le altre opere agiografiche del poeta valdobbiadenese sono in prosa, è evidente che avverte profondamente il suo debito.
Forse nell’attimo stesso in cui la luce torna ad abitare nei suoi occhi, fa voto a Martino di recarsi a Tours, la città dove è stato vescovo.
Verso la fine del 565 Venanzio Fortunato lascia Ravenna e l’Italia. Non vi tornerà mai più.
Un viaggio senza ritorno
Perché Venanzio lascia la sua terra? Perché non pensa mai ad un ritorno, pur attraversato da dolorante nostalgia, come abbiamo appreso? Perché, come si intuisce, considera abbastanza presto definitivo il suo allontanamento nonostante la famiglia, il sangue, l’oggetto del suo amore siano altrove?
É, nella biografia venanziana, il problema dei problemi, il nodo perennemente irrisolto.
Il paradosso di cui ho parlato in premessa.
Di lui sappiamo praticamente tutto e in realtà non sappiamo nulla.
Leggiamo i suoi Carmina e conosciamo i suoi gusti, i suoi viaggi, le sue letture, le sue amicizie. Ne apprezziamo l’acutezza di osservatore dei costumi, sorridiamo attraverso il filtro della sua ironia, partecipiamo alle sue riunioni conviviali e alle sue sodalità grazie alla bonomia sorridente e paciosa con cui ce ne riferisce. Insomma se non proprio le minuzie, almeno le quotidianità abbastanza banali.
Però, come abbiamo appena detto, non sappiamo bene nemmeno dove è nato.
E tante, troppe sono le cose che ignoriamo di lui.
Quali sono stati i suoi studi? Dove li ha fatti? Quali i suoi rapporti con Aquileia? Quale il suo curriculum a Ravenna?
E poi il grande interrogativo. Perché lascia e perché non torna.
Quando Venanzio si reca in Gallia non pare particolarmente incalzato dal desiderio di recarsi a Tours a pregare nei luoghi martiniani. A sciogliere il suo voto.
È un vagabondo, desideroso di conoscere persone, luoghi, situazioni. Un errante, uno che non sa bene cosa vuole fare.
O forse lo sa troppo bene, come vedremo, ma lo tiene nascosto, si giostra, si barcamena.
Andiamo con ordine. Di Martino, è indubbio, Venanzio subisce il fascino. È possibile, anzi certo, che il valdobbiadenese sentisse nell’ungherese una sorta di precursore, un uomo così senza patria da avere per patria il mondo.
Via dalla Pannonia, Martino, via dalla sua Sabaria (che è l’attuale Szombathely) in cerca di una cittadinanza più universale, di un fare e di un agire più a propria misura.
Via dalla sua Vallis Duplavis, Venanzio. Con lo stesso tarlo a rodergli l’animo. Due destini in fieri, poco disponibili a ricalcare orme già battute da altri nella propria avventura esistenziale. Vogliosi di nuovo, di diverso, di mai sperimentato.
Nel decennio 565-575 (cioè: tra la partenza da Ravenna e la composizione della Vita sancti Martini), Venanzio gira inquieto per le Gallie.
Tra il 566 e il 567 è a Parigi e poi a Tours. I dignitari merovingi lo accolgono con calore e affetto. Poi è in Spagna, a Braga, infine a Poitiers dove domina la personalità di Radegonda, che nel 538 era andata sposa a Clotario e poi si era data alla vita claustrale, consacrata da Medardo, vescovo di Noyon .
DALL’ANTOLOGIA DEI CARMINA
(nel volume c’è il testo latino a fronte)
IL FIUME GERS
(I, 21)
Forse, generosa Garonna, la tua fama sarebbe minore se un altro fiume avesse maggiore portata d’acqua. Perché qui il Gers fluisce con tenue corrente e quella povera fonte fa risaltare la tua ricchezza. E credo proprio che se uno mette a confronto quanto sono dissimili, il Gers è un ruscello e tu sei il Nilo. Lui è un servo che si avvicina a te e tu lo domi con la tua autorità, tu, Eufrate delle Gallie, lui fiumiciattolo nascosto. Tu alimenti l’oceano con le tue turgide correnti, lui cerca di far crescere le tue acque. Quando, in particolar modo, la torrida estate opprime le terre e il campo abbandonato reclama acqua nella pianura riarsa, quando il sole scava il terreno con i suoi raggi ardenti e la calura taglia la zolla con aratro di fuoco, il Gers fatica a dispiegare il suo corso inaridito e trema assieme al suo pesce. Il fiume si ritira e il pesce lambisce le sabbie vuote, non più casa sua, lui esule, lontano dalle acque. Il fiume si consuma e le sue acque si fanno fango: è terra sterile dove un tempo era onda rapace. Il fiume brucia, viene a mancare il sollievo della frescura, in penuria, triste e malato come vuole il suo nome. Non un sorso per il viandante in cammino: e come potrebbe ristorare gli altri chi ha già sete per conto suo? Il fiume desidera acqua e tu provi a convogliare in lui altre correnti: ma come fai a chiamarlo fiume, se sei tu -un uomo!- a irrorarlo? La ruota avanza e lascia il suo segno sulle sabbie fluviali: dal solco emerge e trasuda l’acqua. Percorri questa strada col tuo cavallo sotto il segno del cancro e solo lo zoccolo, al suo piantarsi, sarà coperto dall’acqua. Ci è capitato di vedere un pesciolino emergere dal fango, la melma lo imprigionava e lui era un naufrago di terra. Qui non c’è fiume e non c’è terreno, né campo né onda: nessuno può condurre l’aratro in un luogo inospitale perfino per i pesci. Una rana, nuotando solitaria nella palude, emette queruli lamenti: non ci sono più pesci ed è un re straniero a dominare le acque. Ma se per caso una pioggerella -tanto stentata da bagnare appena il terreno- cade dalle nubi, eccolo subito gonfiarsi minaccioso. Da una piccola nube egli trae un grande orgoglio: un fossato di colpa diventa il mare. Avanza torbido ed è lui ad avere bisogno di essere lavato da acque pulite, mai costante, qualche volta nulla, qualche volta troppo. La corrente, non più frenata dai suoi argini, invade tutte le strade e vomita nei campi fittamente seminati ciò che ha strappato alla montagna. Sembra proprio un tiranno: infuria col suo gorgo ribollente, odia il proprio corso normale, devasta i frutti dei campi. Il raccolto si disperde tra i flutti, i pesci finiscono nei prati. È capovolto l’ordine naturale: pesci sulla terra, messi nelle acque. I pascoli, un tempo frequentati dalle pecore, vengono offerti alle rane. I prati ospitano i pesci, i flutti trascinano le greggi. Un siluro, sbalzato fuori dalla corrente, trova la sua tana nei campi e si catturano più pesci sulla terraferma che poco prima in acqua. Le reti stravolgono i campi che attendevano invece la sarchiatura, l’amo si conficca dove prima era infisso un palo. Identica sorte attende i pesci, sia quando il fiume è in secca sia quando è in piena: ora giacciono nel fango, ora stanno in esilio nei campi.
Ma perché spendere tanta tristezza per un fiumiciattolo? Le mie parole lo inaridiscono ancor più e non gli recano acque. Brucia già per conto suo. Perché dovrei aggiungere altri vapori e far raddoppiare la canicola estiva? Non ci resta che consolarlo con questo solo titolo di merito: privo delle sue acque, il Gers ci regala i suoi pesci.
INNO IN ONORE DELLA SANTA CROCE
(II, 6)
Avanzano i vessilli del re,
rifulge il mistero della croce,
il creatore della carne, nato da carne
fu sospeso a questo patibolo.
Le membra trapassate dai chiodi,
le mani e i piedi in tensione,
per il dono della redenzione
qui egli fu vittima immolata.
Qui fu anche ferito
da feroce punta di lancia,
per purificare noi della colpa
effuse l’onda del suo sangue.
Si è compiuto ciò che ha predetto
David con profezia di verità
quando proclamò alle nazioni:
Dio instaurò il suo regno dalla croce.
Albero splendido e rifulgente,
ornato di porpora regale,
scelto come giusto legno
per toccare così santo corpo.
Tu felice, che alle tue braccia
fu sospeso il riscatto dell’umanità,
fosti bilancia del suo corpo,
rapisti la preda del Tartaro.
[Salute a te, croce, sola speranza
in questo tempo di sofferenza,
aumenta la giustizia per i buoni,
regala il perdono ai cattivi.]
Effondi aroma dalla corteccia,
superi il sapore del nettare,
gioisci di fecondi frutti,
plaudi al grandioso trionfo.
Salve altare, salve vittima,
sofferenza e gloria.
Qui la Vita ha sconfitto la morte
e grazie alla morte ha restituito la vita.
IL CUOCO CHE GLI PORTA VIA LA BARCA
(VI, 8 )
Mie preoccupazioni, perché vi lamentate con tanta insistenza? Orsù, dolore, libera alla fine il mio cuore! Perché mi devi ricordare l’accaduto? Già mi logora il fardello mio solito. Perché dovrei raddoppiare il peso di cui vorrei liberarmi? Il mio -io vado ramingo, esule dalle patrie contrade- è un peregrinare ben più triste di quello di Apollonio, straniero e naufrago in mare. Quella volta che giunsi a Metz, un cuoco del re, attento a quando mi fossi assentato, mi portò via barca e marinai: lui che toglie dal fuoco il cibo a rischio di bruciarsi le mani, non sa frenarsi davanti ad una barca ben protetta dalle acque. Buiocuore, mangiafumo, nerofuliggine: ha la faccia simile a una delle sue marmitte. Le sue armi -padelle, cuccume, terrine, vassoi e trepiedi- lo hanno pitturato di sudiciume. Altro che cantarlo coi miei versi: per rendere l’oscena immagine d’un uomo di pece, un frego col carbone gli farei. Proprio una cosa abietta, un evento contro ogni giustizia perché i miei diritti valgono meno del brodino di un cuoco. Il codice cede il passo alla pignatta e di restituirmi la barca manco si parla. E tuttavia, col consueto affetto, ecco porgermi aiuto Villico, che pasce e moltiplica il gregge del Signore. Si prende a cuore la cosa, si preoccupa, accorre con una barchetta da due soldi: io ero però ormai zuppo di acqua, vento e fiume. Feci scendere i miei compagni di viaggio, di lì dovevano proseguire a piedi. Dentro o fuori? Se tutti fossero entrati, tutti avremmo fatto naufragio. Alla prima minaccia di pericolo, saremmo andati sotto e nessuno sarebbe sopravvissuto a testimoniare la rovina. Io ci andai così vicino, pur avendo sbarcato tutti, che i flutti -un’ondata dietro l’altra- mi lambivano i piedi. Dissi all’acqua: “Molto gentile, ma vattene, non voglio fare il bagno!”, ma lei insisteva a inondarmi i piedi. Arrivo a Nauriaco e riferisco le mie sventure al re. Rise e con parole di comprensione diede disposizione che mi fosse recata una imbarcazione. La cercano, ma fino a quando tutta la corte reale era in crociera sul fiume, non fu possibile trovarmi un po’ di naviglio. A prestarmi il suo conforto, stette con me solo Gogone: certo non nega agli amici ciò che concede a tutti. Con molta calma si rivolge a Pappolo, un conte lì presente, perché mi procuri una barca qualsiasi. Si guarda intorno e vede una barchetta sulla spiaggia: troppo piccola, tuttavia, per accogliere tutti i nostri bagagli. E, data la situazione, mi trattiene un po’ a Nauriaco, generoso di tutto ciò che il luogo poteva offrire. Reca piccole cose, tuttavia, ma a me basta l’intenzione: non è mai un piccolo aiuto quello che ti porge un amico. Mio amabile e cortese amico: aggiunge dei boccali per il vino che fu possibile trovare in quelle contrade. Così, Pappolo, mi hai messo a disposizione una dolce nave. Vivi felice, conte, mio dolce amico.
A GOGONE
(VII, 4)
Nuvole che avanzate verso di me, incalzate dall’impetuoso Aquilone, mosse dalla ruota oscillante attorno all’asse sidereo, ditemi come sta il mio amico Gogone, di quali piacevoli affari si sta serenamente occupando. Forse sta dimorando in riva al Reno dalla corrente capricciosa per pescare dalle acque il pingue salmone, forse sta camminando lungo il corso della Mosella nutrice di vigne, perché la lieve brezza temperi la calura del giorno quando le fronde e il fiume mitigano la canicola meridiana. Fresca è l’ombra delle viti, fresche le onde che si succedono alle onde. O lo trattiene la Mosa dal dolce mormorio che la gru, l’oca, l’anitra e il cigno frequentano? Qui fiorisce triplice commercio: volatili, pesci, barche. O risiede sul corso dell’Aisne che si frange sulle sponde erbose le cui acque alimentano pascoli, prati e campi? Piuttosto lo trattengono l’Oise,la Saar, il Chiers, la Schelda, la Sambre, la Somme, la Sûre? Oppure il fiume che bagna Metz e trae il suo nome dal sale? Forse sta perlustrando i boschi e i monti dove ha stabilito il quartiere d’estate perché vuole catturare selvaggina con la rete o ucciderla con la sua lancia? Magari sono le foreste delle Ardenne e dei Vosgi a risuonare delle frecce che recano morte a cervi, caprioli, alci e bisonti. O colpisce proprio tra le corna il forte bufalo e nemmeno orsi, onagri e cinghiali riescono a ritardare la propria fine. E se stesse coltivando le sue terre tracciando solchi sul maggese bruciato dal sole mentre il toro patisce sul collo robusto il peso dell’aratro? Oppure siede sereno nella grande sala del palazzo mentre i cortigiani gli stanno attorno e lo acclamano con affetto? O col dolce Lupo riesamina le leggi che riguardano la beneficenza e di comune accordo producono squisito miele per nutrire i poveri e consolare le vedove? E perché i fanciulli possano avere un tutore e sostegno i poveri? Qualunque cosa facciano, possa il successo coronare le loro azioni. E sia loro concesso di godere dell’amore di Cristo re. Vi prego, o venti che andate e venite, portate loro notizie di Fortunato.
IL VIAGGIO IN BATTELLO
(X, 9)
Ero diretto all’incontro con i miei sovrani, là dove si ergono le mura di Metz. I miei signori mi scorgono e mi fanno scendere di cavallo. Subito gli ordini: divento un marinaio e proseguirò sulla Mosella, a forza di remi. Mi affretto a scendere verso le acque frementi. Ecco il pilota salire di corsa sulla nave dalla linea slanciata: la prua volava sulle onde senza essere spinta dai venti. Ad un certo punto si deve passare tra scogli nascosti sulle due rive, il letto si restringe e le onde salgono. Qui la forza della corrente ghermisce la prua, la spinge, la avviluppa e l’acqua ribollente sta quasi per riempire la pancia della barca. Ma ce la cavammo e allora mi fu possibile contemplare gli ampi spazi delle campagne: mi dimentico del fiume e mi rivolgo alla bellezza dei campi. Più a valle mi catturano i gorghi dell’Orne: la portata raddoppia e il nostro procedere si fa ancora più spedito. Le acque defluiscono irruente e la nostra nave deve muoversi con cautela. Mai vorrei andarmi a ficcare in una nassa assieme ai pesci. Sulle rive fumano i camini delle case contadine e noi arriviamo dove la forza della Sûre si scarica nella Mosella. Di là, tra colline che si innalzano e il fondo della valle, scivoliamo sulle docili onde fino alla confluenza della Saar. Arrivo a Treviri, con la veduta immensa delle sue mura, città nobile tra le nobili città e a sua volta capitale. Seguiamo il fiume e passiamo tra le antiche dimore dei senatori, dove vestigia maestose hanno lasciato il loro segno. Da ogni parte scorgiamo montagne dalle vette minacciose: là in alto un picco tagliente fende le nubi, cime scoscese svettano con punte inaccessibili, cumuli di scabra pietra si elevano fino alle stelle.
Ma queste aspre rocce non possono restare sterili. In una parola: qui i sassi generano e fanno scorrere vino. Da ogni parte si possono ammirare colline rivestite di vigneti e una dolce brezza agita chiome di pampini. Le viti si addensano, ben ordinate, con le loro radici che affondano nella pietra e con disegno regolare salgono fino alla cima. La coltivazione tra quei sassi aguzzi è una gioia per i contadini: la splendida vite rosseggia sul candore della petraia, dove il duro sasso genera grappoli dolci come il miele ed è splendente l’uva, florida su quella pietra infeconda. Qui le vigne sono chioma ai piedi di una montagna calva e la verde ombra copre la miniera disseccata.
Il vendemmiatore ne stacca grappoli colorati e a sua volta, mentre li raccoglie, è sospeso su quelle rocce a strapiombo. Che delizia per i miei occhi e che squisitezze gustai: momenti di gioia, marinaio al seguito dei miei sovrani.
E poi ancora a seguire il corso del fiume fino a Contrua, luogo di ritrovo dei battelli che fu capitale di antica nobiltà. Infine pervengo alla confluenza dei due fiumi: qui si congiungono il Reno spumeggiante e la Mosella ricca di pesci.
Per tutto il viaggio le onde ce ne offrirono: le acque brulicavano, a disposizione dei nostri signori e re. Davvero nessun piacere poteva mancare a quel mio viaggio: mi pascevo delle Muse, il mio orecchio beveva i loro canti. Le montagne vibravano al suono emesso dalle cornamuse e le rocce scoscese rimandavano l’eco delle melodie. E subito entravano con delicati sussurri le corde di bronzo, mentre la boscaglia rispondeva coi suoi flauti dalle alte cime.
La musica, in un fremito, ora cambia di intensità, ora si fa piana e cantabile: dalla roccia ritorna limpida come quando scaturisce dalle corde metalliche. La dolcezza dei canti riunisce le due rive distanti e la melodia ha una sola voce, sulle acque e nella vallata. Ridare gioia al popolo, ecco ciò cui mira la generosità dei re, sempre sollecita nella ricerca di come porgere aiuto. Fardello sulla mia imbarcazione, ora di là avanzo e mi dirigo di gran voglia verso la rocca della cittadella di Andernach. Ebbene: sugli ampi pendii, da questa parte, si distendono i vigneti, dall’altra si apre la fertile pianura. E inoltre la ricchezza di quel luogo meraviglioso supera ogni altra ricchezza perché qui la gente ha un secondo raccolto dal fiume. Così quando, nella reggia, i re siedono in trono e offrono feste conviviali invitandoci alla loro mensa, si guarda nelle reti e si libera dalle maglie il salmone: il re, sempre assiso in trono, conta i pesci. Quando vede il pesce balzare dall’acqua è contento per la sua mensa e si riempie di gioia al venire della preda. Ha davanti agli occhi la prosperità e quindi comunica la sua gioia al palazzo: prima mangia il pesce con gli occhi e poi si nutre di quel cibo. È normale anche che si presenti un cittadino straniero della regione del Reno e la gente del posto gioisce di quella abbondanza imbandita. Il signore conceda ancora a lungo questa visione ai nostri signori. E voi, signori, date sempre al vostro popolo giorni felici. Possa sempre scendere su tutti la gioia dei vostri volti sereni e la vostra grandezza trovi rispondenza nel benessere dei vostri sudditi.